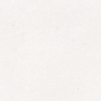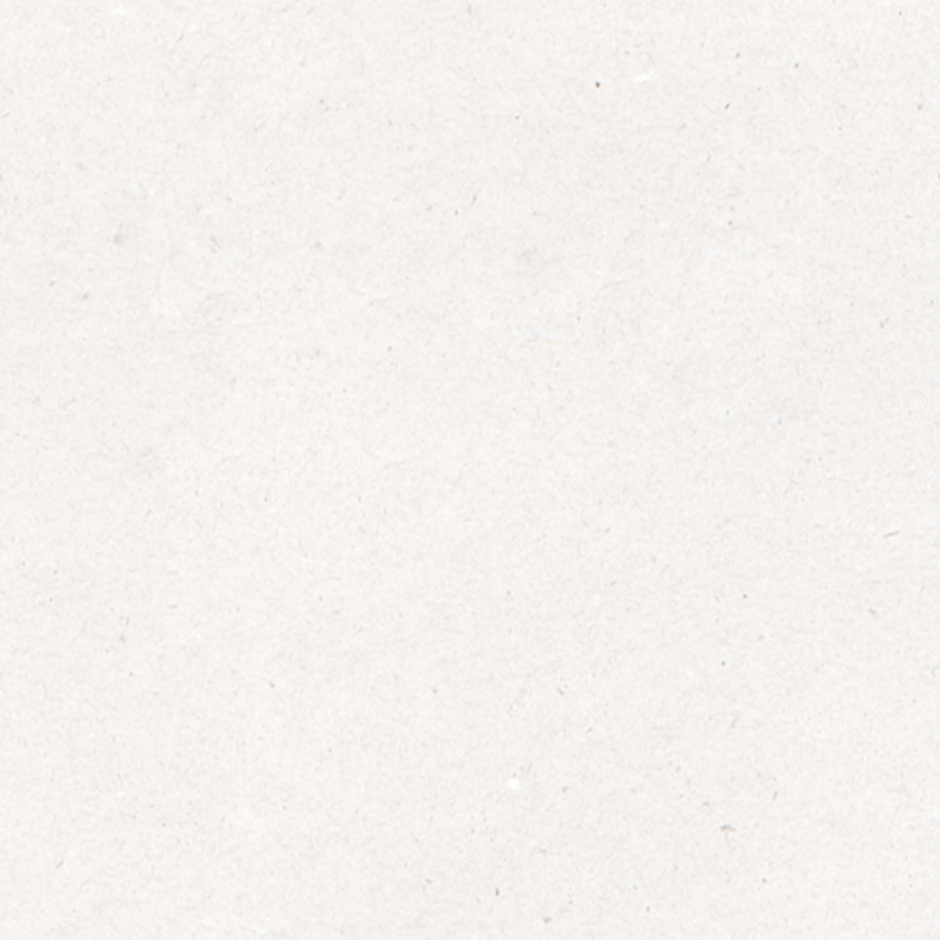parte 2°
nazionalismo e socialismo
in Medio Oriente
Il Terzo Mondo entrò in una nuova fase politica ed economica quando l'Unione Sovietica con Khruscev ruppe il suo tradizionale isolazionismo, e si pose in concorrenza con gli occidentali per il sostegno alle economie dei paesi emergenti. Conseguenza di tale politica fu l'estensione della guerra fredda, che aveva fino ad allora interessato solo le nazioni limitrofe al blocco sovietico, a tutto il resto del mondo, ed in particolare a quelle regioni ritenute vitali dagli Occidentali. Di fronte a tale mutamento politico nel 1959 il futuro presidente americano Kennedy osservò: “Da quando i russi avviarono i loro aiuti e la loro penetrazione commerciale nel mondo sottosviluppato, cinque anni or sono, avrebbe dovuto apparire chiaro che, ove l'India cadesse, e l'America Latina ci voltasse le spalle, e il Medio Oriente scivolasse al di là del sipario di ferro, allora non basterebbero a salvarci né i satelliti spaziali, né gli aerei mossi dall'energia nucleare, né i sottomarini atomici” . Lo statista americano rimproverò all'amministrazione Eisenhower di non aver sostenuto l'Egitto nel finanziamento della diga di Assuan, di aver posto alcune restrizioni ai prestiti a favore dei paesi dell'America Latina, e in occasione del congresso del partito democratico nel Wisconsin del 1959, denunciò che “Il blocco cino-sovietico già ci supera nell'assistenza economica alle zone chiave, ai potenziali settori d'attrito mondiali: Indonesia, Ceylon, Repubblica Araba Unita cioè Egitto e Siria, Afghanistan, Yemen e, ultimamente Irak, Nepal ed Etiopia” .
La sfida sovietica nel mondo afroasiatico destò allarme e determinò un mutamento nei rapporti fra paesi industrializzati e paesi poveri, consentendo a quest'ultimi un comportamento più spregiudicato. Si ebbero quindi diverse crisi alla cui origine vi era l'esproprio di società e beni stranieri da parte dei paesi del Terzo Mondo. Molte di queste iniziative, come la nazionalizzazione dell'Anglo Iranian Oil Company e della Compagnia del Canale di Suez vennero realizzate senza neanche un tentativo di negoziazione con i paesi interessati, e furono la causa di gravi crisi a livello internazionale. Diverse contese si risolsero a favore dei paesi mediorientali, ma in realtà portarono scarso beneficio alle popolazioni locali, e la politica economica aggressiva di questi paesi, ha avuto come conseguenza la maggiore diffidenza del capitale straniero ad investire in queste regioni nonostante le potenzialità che esse offrivano.
Per molti decenni il Medio Oriente venne governato da un gran numero di monarchi e sceicchi piuttosto rissosi, ma che accettavano abbastanza di buon grado il dominio britannico. La regione rivestiva notevole interesse per il petrolio, tuttavia fino all'avvento di Nasser in Egitto non sembrava che dovesse essere turbata da avvenimenti di carattere eccezionale. Nel 1945 i paesi arabi indipendenti su iniziativa britannica diedero vita ad una organizzazione unitaria, la Lega Araba, con la quale gli stati membri si impegnavano a risolvere attraverso negoziati le loro dispute. La Lega costituì un organo consultivo che diede un suo contributo nell'allontanamento delle truppe francesi dalla Siria e nella lotta ad Israele, ma non costituì la base per una unione araba, e negli anni successivi non mancarono gravi dispute all'interno della stessa.
I primi sintomi di malessere del Medio Oriente si manifestarono in Palestina dove negli anni successivi alla prima guerra mondiale si ebbe un vasto movimento migratorio costituito da ebrei provenienti dall'Europa centrorientale che iniziarono a stabilirsi in quella parte di territorio dove erano già presenti comunità ebraiche. Dapprima il movimento fu visto con favore dai britannici ma successivamente di fronte alle proteste degli arabi, il governo inglese iniziò a porre difficoltà alla massiccia immigrazione. La costituzione dello stato ebraico incontrò l'opposizione anche delle società petrolifere che operavano nella regione mediorientale le quali invitarono Truman a rivedere la sua politica a favore dello stato ebraico. L'odio fra le due comunità, alimentato da personaggi intolleranti come il Muftì di Gerusalemme (che organizzò raid contro i nuovi arrivati ma anche contro gruppi arabi moderati), e da gruppi fanatici ebrei come i membri della banda Stern, portò a numerosi disordini e scontri armati.
Nel '47 la Palestina venne divisa dall'ONU in due stati indipendenti, ma questa soluzione venne criticata dalla popolazione araba locale, la quale essendo maggioritaria preferiva la costituzione di uno stato unico dove avrebbero potuto prevalere sugli sgraditi intrusi. L'anno successivo nel momento stesso in cui i soldati britannici si ritiravano, lo stato israeliano venne attaccato dagli arabi palestinesi e da una coalizione di paesi arabi vicini. Gli israeliani sorretti dalle comunità ebraiche internazionali e dal blocco dei paesi comunisti che intendevano contrastare la presenza britannica nella regione, poterono resistere e anzi furono in grado di infliggere pesanti perdite agli attaccanti. La sconfitta araba ebbe molte conseguenze politiche, rafforzò quei movimenti nazionalistici e progressisti che disegnarono il nuovo assetto della regione, e segnò la fine della nazione palestinese che venne assorbita da Israele, Giordania ed Egitto.
La contesa con Israele non produsse invece un riavvicinamento fra le monarchie arabe, e nel corso degli anni Cinquanta non mancarono contrasti fra i sovrani hascemiti che regnavano su Irak e Transgiordania, e i sauditi dell'Arabia sostenuti da Siria ed Egitto che vedevano in Feisal e Abdullah due sostenitori del potere britannico nella regione.
Nel 1951 la rivoluzione di Nasser cambiò completamente la geografia politica della regione. Come nel Sud-Est asiatico prevalsero le istanze più estremistiche. I governi rivoluzionari si adoperarono molto nel campo delle nazionalizzazioni e della riforma agraria, ma tale politica non venne associata ad iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita delle masse, per la promozione dell'istruzione, per una migliore situazione sanitaria. Le popolazioni vennero lasciate a sé, mentre tutte le risorse vennero concentrate in una politica aggressiva nei confronti di Israele e gli altri paesi vicini. Il proclamato panarabismo, non fu altro che il tentativo di imporre la propria leadership sul resto del mondo arabo.
L’ascesa politica di Nasser portò ad uno stravolgimento del Medio Oriente di vasta portata. Molte furono le monarchie rovesciate e sostituite da governi rivoluzionari sostenuti dai militari. Il movimento nasseriano fu un movimento fortemente nazionalista, socialista e laico, fra i provvedimenti adottati si ebbero la riforma agraria, la nazionalizzazione delle aziende, la emancipazione delle donne, e la persecuzione dei movimenti islamici.
La crescita demografica e la cattiva gestione del territorio, ha favorito la desertificazione e aggravato la situazione delle limitate risorse idriche della regione, che potrebbe divenire in un futuro non lontano il maggiore problema di quell'area, la causa di nuovi conflitti, e portare allo stravolgimento delle attuali alleanze.
IL PANARABISMO DI NASSER
Fra le conseguenze della sconfitta araba in Palestina vi fu la fuga di centinaia di migliaia di arabi palestinesi verso i territori vicini, l'assassinio del re Abdullah di Giordania, ed una successione di colpi di stato militari a Damasco, ma le conseguenze più significative della guerra si ebbero in Egitto con l'avvento di un governo rivoluzionario.
L'Egitto, che da sempre aveva svolto un ruolo guida nel mondo arabo, fu anche il primo paese dell'area a dare il via ad una serie di sommovimenti che dovevano disegnare la nuova geografia del Medio Oriente. Decaduto definitivamente il controllo ottomano sull'Egitto nel 1914, si organizzò nel paese un vasto movimento nazionalista, il Wafd, favorevole alla modernizzazione del paese, alla creazione di uno stato costituzionale, e al pieno affrancamento dalla influenza britannica. Negli anni Venti il partito si impose alla guida del paese in contrasto con i circoli della corte, ma progressivamente il movimento attenuò la sua intransigenza, e negli anni successivi non seppe porre un freno alla corruzione di palazzo, situazione che favorì l'ascesa di nuovi gruppi politici. Nel 1951 l'anziano capo del Wafd, Nahas Pascià, condusse la battaglia per l'abrogazione degli accordi con la Gran Bretagna sull'amministrazione congiunta del Sudan e sul Canale di Suez, ma le proteste nel paese portarono al pronunciamento militare capeggiato dal prestigioso generale Neguib e dal più radicale Nasser, capo del gruppo degli ufficiali liberi che nel giro di breve tempo prese il sopravvento sul primo.
Uno dei più attivi movimenti di opposizione al regime di Faruk fu quello dei Fratelli Mussulmani sorto nel 1928, e con alterne fortune arrivato ai giorni nostri. Il movimento costituiva la sintesi fra posizioni integraliste decisamente antidemocratiche e posizioni radicali. Nel suo statuto del 1928 si leggeva che l'Islam era “una legge completa per guidare tanto questa vita che l'altra”, che occorreva contrastare “ogni giornale, libro, pubblicazione che neghi gli insegnamenti dell'Islam”, e favorire il rilancio dell'Islam in tutto il mondo . Il movimento che ebbe diffusione anche negli altri paesi mediorientali, venne sciolto da Nasser, ma nonostante le persecuzioni riuscì ad avere un ruolo attivo nelle vicende mediorientali successive.
Il nuovo governo mise in atto una riforma agraria abbastanza radicale che mise fine alla grave situazione esistente nel paese, dove l'85% della popolazione rurale non era proprietaria della terra che lavorava, ma il paese non fece passi in avanti sul piano della democrazia. Secondo il giornalista italiano Romano Ledda il governo Nasser “Sulla via giusta di colpire e disperdere tutti i tradizionali partiti di politicanti corrotti... ha tuttavia colpito quel po' di vita democratica che si aveva intorno alla sinistra egiziana impedendo ogni sviluppo democratico del paese” e ricordava a tal proposito che nel paese i sindacati non erano altro “che delle diramazioni dirette del potente apparato statale, da cui discendono tutte le decisioni” . La riforma agraria diede vita ad un esteso sistema di cooperative che di fatto prevedeva una delega di poteri a favore di funzionari governativi con scarsi benefici per i lavoratori. Come altri paesi del Terzo Mondo venne dato impulso all’industria siderurgica e alle nazionalizzazioni delle imprese (piano comunque abbandonato verso la fine degli anni Sessanta), ma il disordine nella organizzazione economica e l'eccessivo prelievo fiscale impedì il decollo dell'economia del paese. Un altro importante obbiettivo di Nasser in quegli anni fu la realizzazione della grande diga di Assuan che avrebbe consentito un aumento considerevole della produzione di energia elettrica e delle terre coltivabili; il progetto fu realizzato ma molte altre attività dovettero essere abbandonate per gli eccessivi impegni in politica estera che il Rais si era imposto. Secondo il presidente americano Nixon Nasser “aveva un carattere instabile, impaziente, dittatoriale ed era posseduto da grandiose ambizioni che presero il sopravvento sulle necessità pratiche della gente. Mentre la stragrande maggioranza degli egiziani aveva disperato bisogno di generi di prima necessità, egli volse le già scarse risorse nazionali al soddisfacimento della sua ansia di avventure internazionali... cercando di distorcere qualsiasi piano di unità panaraba che non prevedesse la sua direzione” tuttavia egli suscitò un grande entusiasmo nelle folle; “Ciò che rese Nasser tanto amato” è sempre Nixon che parla “fu la capacità di restituire l'orgoglio, l'anima e lo spirito della sua nazione... Quando Nasser dimostrò di «essere qualcuno» tutti gli arabi si sentirono chiamati in causa, tutti si sentirono di «essere qualcuno», di riflesso alla sua figura. E per coloro che mancano delle soddisfazioni materiali, questo genere di gratificazioni può avere un significato di gran lunga superiore che per coloro che non hanno bisogno di nulla” .
Nasser non conquistò la simpatia di tutte le forze progressiste del mondo arabo e secondo il leader tunisino Bourghiba “gli arabi non si sono mai ammazzati con tanta ferocia tra di loro come da quando Nasser si è assunto la sacra missione di unirli” . Lo stato di Nasser non conobbe gli eccessi e le persecuzioni di altri regimi tuttavia fu uno stato accentrato e non democratico. Secondo lo studioso francese Lacouture: “Per molti egiziani le idee di democrazia rappresentativa e di parlamentarismo si confondevano con la presenza straniera e gli intrighi di palazzo. E il partito che incarnava l'idea di emancipazione nazionale e di democrazia «all'occidentale» il Wafd, si era di volta in volta compromesso con i britannici e con la monarchia, lasciandosi prendere dalla corruzione e dalla demagogia” .
Nasser si pronunciò a favore del socialismo, ma la sua politica era diretta essenzialmente verso un rigoroso controllo politico dell'economia e alla lotta ai grandi proprietari terrieri, non anche al miglioramento delle condizioni economiche delle masse che continuarono a vivere nel medesimo stato in cui da sempre si trovavano. Le numerose iniziative economiche intraprese da Nasser non migliorarono infatti la situazione del paese; secondo il settimanale Jeune Afrique nella seconda metà degli anni Sessanta in Egitto “Dopo la scomparsa degli articoli di lusso o di semilusso, mancano ora gli articoli di prima necessità. L'olio di oliva è diventato un prodotto rarissimo, la carne è razionata e lo zucchero ugualmente, come pure il riso” . La partecipazione alla vita politica in Egitto non fu partico-larmente ampia, tuttavia fra i molti governi militari del Terzo Mondo, quello di Nasser fu quello che si caratterizzò maggiormente per la capacità di mobilitazione delle masse.
Per raggiungere i suoi fini Nasser strinse un'alleanza con l'Unione Sovietica ma all'interno del suo paese non diede spazio ai comunisti, che come anche nei paesi alleati, furono oggetto di persecuzioni. Nasser in pubblico condannava l'imperialismo e gli Stati Uniti, ma in privato sapeva dosare i rapporti fra le grandi potenze e in un incontro con Nixon nel 1963 non mancò di esporgli la sua gratitudine per aver “frenato” gli alleati europei in occasione della grave crisi di Suez.
Il successo di Nasser è legato soprattutto alla grande sfida lanciata ai paesi occidentali. Nel '56 dopo la partenza delle ultime truppe britanniche, improvvisamente Nasser decise la nazionalizzazione della Compagnia del canale di Suez. Nel suo discorso ad Alessandria in cui illustrava le direttive della nuova politica sostenne di voler agire per “il consolidamento dei nostri principi di dignità, di libertà e di grandezza, per l'attuazione di uno Stato indipendente, di una vera indipendenza politica ed economica... Grazie alla sua rivoluzione, l'Egitto ha lottato per portare i suoi problemi su di un piano diverso da quello della preghiera e dell'elemosina” . L'iniziativa messa in atto senza l’apertura di un negoziato con i paesi interessati, irritò ovviamente Francia e Gran Bretagna che avevano le maggiori partecipazioni azionarie nella società, ma suscitarono anche altre proteste, per la decisione del Rais di non garantire la libera navigazione per l'importante via d'acqua. Su richiesta francese il governo israeliano, che intendeva garantirsi dal blocco degli stretti di Tiran, attaccò le truppe egiziane nel Sinai, e nel corso degli scontri il governo francese e inglese richiesero lo sgombero dalla zona del Canale con una minaccia implicitamente più diretta all'Egitto che a Israele. Il mancato ritiro delle truppe egiziane (che ovviamente non intendevano rinunciare al controllo del proprio territorio) portò all'intervento delle truppe anglo francesi, ma il limitato sostegno americano alle nazioni europee costrinse nel giro di breve tempo alla rinuncia delle azioni militari. Se sul piano militare l'Egitto di Nasser aveva perso la guerra, su quello politico riportò comunque un successo che infiammò gli animi di tutta la popolazione araba e provocò un rivolgimento in tutto il Medio Oriente. Si ebbe così la caduta della monarchia in Irak, una serie di azioni sovversive in Libano e Giordania, e la costituzione di un embrione di repubblica panaraba.
Nel 1958 si ebbe quello che può essere considerato uno dei maggiori successi di Nasser, la costituzione della Repubblica Araba Unita con la Siria e lo Yemen del nord. Per molti l'unione dei tre stati sembrò una ingerenza dell'Egitto nella vita politica degli altri paesi arabi, e suscitò una serie di crisi all’interno del mondo arabo. Di lì a pochi mesi si ebbe in Irak un colpo di stato militare organizzato da esponenti nazionalistici in parte vicini alle posizioni di Nasser, la sollevazione della comunità drusa libanese, ed una serie di interferenze nella vita politica della Giordania da parte di Egitto e Siria. Di fronte alla nuova situazione creatasi nella regione, e alla pesante controversia di confine sorta fra Siria e Turchia, Stati Uniti e Gran Bretagna ritennero di dover intervenire con l'invio di contingenti militari in Giordania e in Libano. I due governi occidentali cercarono di favorire il negoziato con l'opposizione, ma la situazione di tensione ebbe termine solo quando nel settembre la Lega Araba presentò all'Assemblea Generale dell'ONU una richiesta (approvata anche da Israele), con la quale si richiedeva che le grandi potenze si astenessero da compiere interferenze nella vita politica della regione.
La pace come era da prevedersi non durò a lungo; nel '61 il governo rivoluzionario irakeno cercò di mettere le mani sul piccolo ma ricchissimo stato del Kuwait provocando l'intervento della Gran Bretagna e della Lega Araba, e nello stesso anno in Siria e nello Yemen si ebbero due rivolte contro l'eccessiva presenza egiziana che portarono alla rottura del RAU. La politica estremista di Nasser subì una tempora-nea battuta d’arresto ma non ebbe comunque termine. Nel '63 due colpi di stato in Siria e in Irak portarono al potere gruppi politici radicali, mentre nello Yemen vennero inviate truppe egiziane a combattere la locale monarchia alleata dell'Arabia Saudita.
Negli anni successivi l'Egitto che aveva raccolto dei successi molto parziali, ridusse i suoi legami con l'Unione Sovietica, moderò la sua politica nei confronti degli altri stati arabi, e arrivò ad un accordo di pace con l'Arabia Saudita sulla questione yemenita, ma la nuova politica riguardava solo i rapporti con gli altri paesi arabi. Nel 1967 il governo egiziano pose nuovamente il blocco degli stretti di Tiran per impedire l'unico accesso dello stato ebraico verso il Mar Rosso, aumentò la presenza di truppe nel Sinai e strinse un'alleanza con Siria e Giordania, ma il complesso lavoro di Nasser non poté essere portato a termine a causa di una radicale quanto abile contromossa di Tel Aviv. Nel giugno di quell'anno l'aviazione israeliana con una spettacolare azione distrusse al suolo la flotta aerea dei paesi arabi infliggendo un duro colpo ai disegni politici arabi. Nei giorni successivi le truppe arabe sottoposte ad incessanti bombardamenti furono costrette ad una precipitosa fuga abbandonando sul campo la maggior parte degli armamenti pesanti. Attraverso la brillante azione di guerra Israele dimostrò la sua determinazione, e conquistò alcuni importanti territori come il Sinai, la Cisgiordania, il Golan che negli anni successivi vennero utilizzati come zone cuscinetto contro eventuali azioni di guerra arabe. Nasser accusò con deliberata menzogna gli Stati Uniti di aver preso parte al raid aereo, ma come notò il giornalista italiano Aldo Rizzo “da allora i discorsi roboanti, quelli che la gente si aspettava da lui, si alternarono a prese di posizioni più sfumate” .
Le due superpotenze non poterono fare molto per porre fine ai combattimenti e per ricomporre la questione, e nel successivo vertice di Khartoum i paesi arabi ribadirono la loro politica verso Israele “No alla pace con Israele, no ai negoziati con Israele, no al riconoscimento di Israele”. Negli ultimi anni Nasser tuttavia sembrò non ostacolare le proposte di pace provenienti dall'ONU e dagli Stati Uniti, e nel 1970 favorì la pacificazione fra giordani e palestinesi lì rifugiatisi, piano che non poté essere portato a termine per la morte del grande leader.
Le regioni fertili dell'Asia Minore sono state dopo la dissoluzione dell'impero ottomano soggette a numerose vicissitudini. Nel 1916 con il sostegno della Gran Bretagna, le popolazioni arabe guidate da re Hussein insorsero contro il governo turco, ma alla conclusione della guerra mondiale l'intera regione venne sottoposta all'amministrazione franco-britannica sotto forma di mandati fiduciari dell'ONU, senza arrivare a quella piena indipendenza a cui le popolazioni di quelle regioni aspiravano.
In Siria e Libano l'amministrazione francese si scontrò con numerose proteste locali e nel 1945 il governo britannico stesso dovette intervenire per fermare l'azione delle truppe francesi impegnate nella repressione delle agitazioni arabe. Ottenuta l'indipendenza al termine della seconda guerra mondiale i due stati conobbero sviluppi profondamente diversi; in Libano si affermò un sistema democratico che prevedeva norme precise per l'alternanza al potere fra le tre principali comunità, maronita, sunnita e sciita, mentre in Siria sunniti e la minoranza alawita davano vita a numerosi contrasti. Le istituzioni vennero ben presto sottoposte al controllo dei militari, che diedero vita a numerosi colpi di stato limitando fortemente la legalità nel paese.
Nel 1954 Kuwatli, un esponente nazionalista degli anni precedenti, instaurò in Siria un regime socialista vicino alle posizioni di Nasser. La costituzione del RAU nel 1958 non ebbe però fortuna a causa dell'ingerenza economica e militare egiziana nei confronti di Damasco, e quattro anni dopo un colpo di stato portò al potere il partito socialista della rinascita araba, meglio noto come Baath in aperto contrasto con i gruppi politici filonasseriani. Negli anni successivi si ebbe un ulteriore spostamento del governo su posizioni radicali con l'attuazione di un vasto programma di nazionalizzazioni e una politica estera di cooperazione con l'Unione Sovietica finalizzata a una nuova guerra contro Israele. Dopo la infelice conclusione della guerra del '67 prese il sopravvento la fazione relativamente moderata e pragmatica diretta dal generale Assad che instaurò un regime totalitario più stabile dei governi precedenti.
Il nuovo governo costituito da una alleanza di Baath, unione socialista araba e partito comunista, diede vita ad uno “stato democratico, popolare e socialista”, e cercò di candidarsi al ruolo di protagonista del mondo arabo attraverso la costituzione di effimere fusioni con altri paesi della regione. Nel corso degli anni il regime diede vita ad una violenta persecuzione del movimento dei Fratelli Mussulmani legato alla maggioranza sunnita, nel corso della quale vennero eliminati migliaia di simpatizzanti, e si pose in contrasto con tutti i paesi vicini. Negli anni Settanta il governo siriano intervenne apertamente nella guerra civile libanese in contrasto con cristiani e palestinesi e cercò di ostacolare il processo di pace con Israele attraverso l'aperto sostegno al terrorismo internazionale. Gli eccessivi impegni sul piano internazionale per un paese privo di grandi risorse economiche ha influito negativamente sul suo sviluppo che in molti casi è risultato notevolmente inferiore rispetto al vicino libanese. Un giudizio profondamente diverso sul dittatore siriano è stato espresso dal ministro degli esteri sovietico Andrej Gromyko, che definì nelle sue memorie Assad “un leader influente e lungimirante, che gode di largo prestigio dentro e fuori del mondo arabo”.
Il Libano nonostante la sua notevole eterogeneità culturale (sono presenti nel paese cristiani maroniti, greco ortodossi, armeni, mussulmani sunniti, sciiti e drusi) ha conosciuto un periodo di relativa stabilità e benessere economico che le ha consentito di divenire il centro commerciale e finanziario del Medio Oriente. Le comunità cristiane guardavano favorevolmente ai paesi occidentali, mentre quelle mussulmane (e la comunità scita più povera in particolare) sostenevano maggiormente la causa panarabista, tuttavia un compromesso fra le due posizioni venne raggiunto, e il paese sembrava avviato ad un sistema di convivenza fra gruppi etnici diversi, una sorta di Svizzera del Medio Oriente, come spesso venne definita. Dopo la breve crisi del '58 il Libano, l'unico paese vicino ad Israele a non aver partecipato ad una guerra contro Tel Aviv, riprese la sua vita tranquilla fino al '73 quando nel paese si stabilirono i palestinesi provenienti dalla vicina Giordania che diedero vita ad una sorta di stato a sé nella parte meridionale del paese. A causa delle tensioni provocate dalla presenza dei profughi scoppiò due anni dopo una violenta guerra civile che degenerò ben presto in uno scontro fra un numero non definito di fazioni in lotta le une con l'altre. Nel 1976 intervenne nel paese l'esercito siriano che prese posizione contro i palestinesi e successivamente contro i cristiani; una vasta operazione militare israeliana diretta contro le basi dei commandos palestinesi nel '78 ebbe scarso successo e quattro anni dopo Israele intervenne nuovamente. Le truppe di Tel Aviv si spinsero sino ai sobborghi di Beirut in una operazione che ebbe grande risonanza internazionale e nel corso della quale vennero assestati alcuni pesanti colpi anche alle forze siriane. Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia intervennero con loro contingenti per favorire la ricostituzione di un governo unitario e rappresentativo nel paese che incontrò tuttavia numerose difficoltà. La pace venne riportata solo quando le principali fazioni libanesi sottoscrissero gli accordi di Taif, con i quali si riconobbe un certo ruolo di supremazia dei siriani nella gestione del paese.
I due regni hascemiti di Transgiordania e Irak già sottoposti al dominio britannico, conobbero anch'essi un'evoluzione molto diversa. Nel '51 il re Abdullah favorevole ad una pace con Israele (dietro il riconoscimento del suo possesso della Cisgiordania) venne assassinato, e al potere salì il giovanissimo re Hussein che nel corso della sua vita ha dovuto superare numerose vicissitudini. Il sovrano salito al potere alla età di diciassette anni, diede vita ad una monarchia costituzionale che seppe garantire un rapporto equilibrato fra le diverse componenti della nazione, tuttavia la politica del governo giordano favorevole alla moderazione e alla pace della regione ha incontrato numerose opposizioni. Nel '58 ci fu un tentativo di rovesciare la monarchia e un attentato (uno dei numerosi) alla vita del re, condotto dai siriani che tentarono anche di abbattere l'aereo reale. Il tentativo ebbe esito infelice grazie anche all'intervento britannico, e negli anni successivi il paese conobbe una relativa stabilità. La Giordania tuttavia risentì fortemente delle conseguenze della guerra del '67; il paese perse con la Cisgiordania la metà delle terre coltivabili e si ritrovò con oltre 200.000 rifugiati palestinesi, che si andarono ad aggiungere a quelli già presenti negli anni precedenti. Tale situazione creò quindi notevole malcontento. Nel settembre del 1970 in seguito ad una serie di dirottamenti aerei si ebbero dei durissimi scontri fra esercito e palestinesi che costituivano ormai il 65% della popolazione, e un'aperta minaccia all'autorità dello stato giordano. La situazione venne resa più complessa dalla presenza nel paese di unità irakene e dal tentativo dell'esercito siriano di penetrare nel paese, fallito in seguito alle prese di posizione di Stati Uniti e Israele. La mediazione di Nasser favorì il ritorno alla pace, sebbene negli anni successivi non mancarono nuove crisi con la vicina Siria, superate grazie al sostegno dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti, mediante il quale il paese ha conosciuto qualche progresso nel campo economico.
In Irak il governo monarchico di Nuri Said ottenne nel periodo del dopoguerra la rinegoziazione a suo favore delle concessioni petrolifere, venne però duramente contestato per le sue buone relazioni con la Gran Bretagna e le sue misure repressive nei confronti dell'opposizione. Nel '58 un colpo di stato militare sorretto da un vasto movimento popolare, nel corso del quale vennero uccisi il re Feisal e il primo ministro, abbatté la monarchia e instaurò la repubblica. Il nuovo governo diretto dal generale Kassem denunciò il precedente Patto di Bagdad, represse la rivolta curda, e tentò di annettersi il vicino Kuwait, ma non venne accolto favorevolmente dai gruppi più radicali, dal Baas (il corrispondente del Baath siriano), dai nasseriani, con i quali si aprì un duro contrasto, e dai comunisti. Anche la riforma agraria promossa dal regime non diede i risultati sperati. Secondo un autorevole esponente arabo “Nelle campagne irakene finora non vi sono organi amministrativi locali democratici, che servano di sostegno al regime democratico repubblicano; vi sono solo funzionari nominati dall'alto, e i proprietari terrieri, anche se il loro potere è diminuito, conservano tuttora la loro potenza economica e una notevole influenza politica” .
Nel '63 in una situazione di grave disordine (che vedeva i comunisti impegnati in un duro contrasto con i socialisti) venne abbattuto il regime di Kassem, e venne sostituito da un nuovo governo militare privo di un reale seguito popolare favorevole ad una politica di nazionalizzazioni nel campo dell'economia e ad una stretta integrazione con l'Egitto di Nasser. La situazione caotica creatasi non ebbe comun-que termine, e cinque anni più tardi un nuovo colpo di stato portò al potere la cosiddetta corrente di destra (legata sempre ai vertici militari) del Baas; il nuovo governo decise la nazionalizzazione della Irak Petroleum Company, la maggiore società petrolifera del paese e strinse legami con l'URSS, anche se la collaborazione con la grande potenza comunista non si tradusse in un migliore rapporto con i comunisti locali. Negli anni successivi il paese sembrò trovare una maggiore coesione interna, tuttavia fra le correnti del Baas rimase alta la tensione e una serie di esecuzioni sommarie in quegli anni indignò l'opinione pubblica mondiale.
Anni di tensioni e violenze non portarono a cambiamenti significativi nella situazione economica del paese. Il giornalista italiano Romano Ledda scriveva nel 1970 che “Il nuovo regime continua a dare una risposta militare ad una questione politica, seguendo in questo la linea di tutti i precedenti regimi... il nuovo regime ha stabilito un rapporto nuovo col campo socialista, che è denso di conseguenze” tuttavia la situazione socio economica del paese rimaneva grave: “...girando per il paese trovi che nelle campagne molto è rimasto sulla carta e che il protagonista e beneficiario della riforma è ancora il contadino medio, una robusta categoria di kulak che detiene le leve del potere, mentre il contadino povero è ancora sottoposto a condizioni di sfruttamento e di miseria” .
L'ascesa al potere di Saddam Hussein nel 1979 produsse un progressivo deterioramento dei rapporti con l'Unione Sovietica e un giro di vite nei confronti dell'opposizione. Negli anni successivi il dittatore lanciò un programma di riarmo che fece dell'Irak la maggiore potenza militare dell'area, e sostenuto dai paesi arabi moderati, mosse guerra all'Iran. La lunga guerra che ne seguì provocò grandi distruzioni e la morte di un milione di persone, senza che il conflitto producesse modifiche territoriali fra i due stati belligeranti.
Conclusa la guerra con l'Iran e repressa con estrema durezza l'opposizione curda, il governo irakeno intraprese nel 1991 l'invasione del Kuwait, dando origine a quello che forse può essere considerato il più duro confronto fra un paese del Terzo Mondo e l'Occidente, ed una delle maggiori sfide alle regole di convivenza civile del mondo libero. La politica del governo irakeno non ha trovato alcuna giustificazione nella pretesa che lo sceiccato costituisse parte del territorio irakeno; durante il periodo di occupazione lo stato kuwaitiano non venne integrato nell'Irak ma depredato e saccheggiato come una terra di conquista. Il dittatore irakeno - che per raggiungere i suoi fini non risparmiò i paesi vicini dalle minacce di ricorrere ai più terribili strumenti di morte - ritenne con tale azione di porsi come leader del mondo arabo, ma incontrò l'opposizione della maggior parte dei governi della regione e quella dei paesi occidentali in maniera compatta. Di fronte ad una ostilità superiore al previsto, Saddam Hussein ritenne di galvanizzare l'entusiasmo delle masse arabe con una serie di minacce ad Israele che fino allora non aveva avuto alcun ruolo nelle vicende, ma se ottenne in questo l'adesione di alcuni movimenti estremistici del mondo arabo, non poté modificare di molto la situazione a livello politico-militare.
Gli Stati Uniti e gli altri paesi della coalizione attraverso una abile strategia riuscirono ad annientare con relativa facilità la potente forza militare irakena, non ottennero anche la eliminazione di Saddam Hussein dal potere, ma riportarono comunque una situazione di pace e di relativa stabilità nella turbolenta regione.
Il regno dell'Arabia Saudita con le sue rigide chiusure al mondo moderno potrebbe non rientrare in questa dissertazione, tuttavia per un certo periodo di tempo anche questo grande “scatolone di sabbia” conobbe alcune significative riforme. Venne abolita la schiavitù e avviato un programma di pubblica istruzione gratuita (dalle elementari all'università) di cui beneficiarono molti cittadini, e diversamente dai suoi predecessori re Feisal evitò la dissipazione delle ricchezze del regno e si impegnò perché i proventi dello stato fossero maggiormente impegnati per fini di pubblica utilità: Industrie, impianti di desalinizzazione per l'acqua (il principale problema del paese), ma anche scuole e ospedali conobbero un notevole sviluppo in quegli anni. Secondo Nixon “Il compito che Feisal si era assunto era quello di guidare la sua nazione sul sentiero del progresso senza mutarne il volto di nazione timorata di Dio” , e in questo ottenne alcuni parziali ma significativi risultati.
Nel 1962 il re nominò ministro del petrolio il principe Ahmed Yamani, personaggio che per cultura e capacità, appariva relativamente aperto alla mentalità occidentale; cosciente dei limiti del paese ritenne che il modello democratico occidentale non si potesse applicare al paese, tuttavia cercò di favorire in una certa misura l'emancipazione del popolo e la modernizzazione del paese. Per l'energico ministro il petrolio costituiva una efficace arma politica per strappare concessioni ai palestinesi e relazioni diverse con l'Occidente, tuttavia seppe evitare gli eccessi e si dimostrò sempre disponibile al negoziato con il mondo occidentale, ritenendo che il crollo economico dell'Europa avrebbe potuto provocare un grave danno ai paesi moderati della regione.
Con la morte di Nasser nel 1970 si chiudeva per il mondo arabo un'epoca che aveva visto la caduta di ben cinque monarchie e il succedersi tumultuoso di numerosi governi, ma con cambiamenti non sempre significativi e scarse innovazioni a favore delle popolazioni, sacrificate alle esigenze belliche e ai propositi nazionalistici dei diversi paesi. Qual'era il problema di fondo del malessere della regione medio-rientale? I territori conquistati da Israele nel '67, l'esistenza stessa di Israele, o altro? Sicuramente la questione israeliana era la più evidente anche perché l'unica su cui ci fosse sostanziale concordia nel mondo arabo, ma secondo Kissinger le cause erano molteplici, interne ed esterne al mondo arabo. Le guerre arabo israeliane avevano causato un gran numero di profughi creando una situazione di estrema gravità, e come confermato da un autorevole esponente arabo “se prima del 1967 la causa palestinese era quella di un popolo arabo fratello, dopo il 1967 grazie alla politica israeliana è diventata lentamente il simbolo dell'umiliazione araba e quindi una causa panaraba” . Anche gli americani riconoscevano le condizioni inumane in cui vivevano quelle popolazioni. Secondo Kennedy “La lor misera e tragica esistenza nei campi di concentramento improvvisati ai confini d'Israele è un focolaio continuo di antagonismi nazionalistici, di caos economico, di sfruttamento delle disgrazie dell'uomo da parte dei comunisti” . Molti leader arabi tuttavia avevano interesse a soffiare sul fuoco della questione palestinese, al fine di creare una situazione di instabilità e favorire le forze estremiste, occorre infatti ricordare che alcuni dei governi più contrari a Israele furono anche di fatto quelli più ostili alla causa palestinese.
In questo clima salirono al potere due leader politici diversissimi che avrebbero caratterizzato il futuro della regione, Anwar El Sadat in Egitto e Muammar el Ghedafi in Libia.
Nel 1971 l'Egitto rinnovò gli accordi di cooperazione con l'Unione Sovietica, ma inaspettatamente con un gesto più comprensibile per il mondo mediorientale che per quello occidentale, l'anno successivo il governo del Cairo decise l'espulsione dal paese dei consiglieri sovietici, per il fondato sospetto che i tecnici della grande potenza eurasiatica agissero per finalità diverse da quelle della cooperazione, e tentassero di interferire nella vita politica del paese.
Non molto tempo dopo la presa di posizione contro Mosca, Sadat lanciò una nuova guerra contro Israele con il proposito esplicito di non abbattere il grande avversario ma di “rimarginare le ferite della guerra del '67”, e di riprendere il Sinai che costituiva territorio egiziano. Le truppe egiziane riportarono un certo successo e misero fine al mito dell'invincibilità di Israele. La prima guerra “non persa” dagli arabi ebbe una vasta risonanza, e segnò profondamente gli avvenimenti successivi in tutta la regione.
La riapertura del Canale di Suez, i minori impegni internazionali, la liberalizzazione economica, e gli incentivi all'investimento straniero, consentirono una certa ripresa economica del paese, che si accompagnò con una serie di misure politiche positive come l'abolizione della censura e della polizia segreta, la ripresa della vita dei partiti, e l'allargamento delle libertà civili. Tali misure tuttavia non accrebbero la popolarità di Sadat, al quale molti negli ambienti estremisti preferivano il più intransigente predecessore. Secondo il giornalista italiano Indro Montanelli “Sadat amava il popolo, il popolo contadino del profondo Sud nubiano di cui era egli stesso originario. Ma non amava le masse e le masse lo sentivano. Folle festanti non gremirono le piazze del Cairo nemmeno per sentirgli annunciare l'agognata rivincita del Kippur. Avesse saputo sfruttare e amministrare la sua vittoria come Nasser sfruttava e amministrava le sue sconfitte, Sadat forse non sarebbe morto... La sua oratoria non era da adunate oceaniche e non possedeva gli accenti drammatici, le pause piene di suspence che le mandano in delirio” . I risultati della nuova politica economica furono comunque inferiori alle aspettative; secondo il giornalista italiano Dino Frescobaldi: “Dopo venti anni di capitalismo di stato la svolta correttiva liberale di Sadat non ha ancora dissipato tutti i sospetti e vinto tutte le diffidenze. Il Cairo ha visto arrivare, spinti dalla curiosità per l'esperimento sadatiano, alcuni fra i maggiori uomini d'affari e imprenditori americani, europei e giapponesi ma finora quasi nessuno ha dimostrato il coraggio di fare grossi investimenti in Egitto. Secondo un osservatore americano «il capitale straniero è spaventato, più che dal rischio di una nuova guerra, dalla confusione delle direttive economiche e dalla riluttanza dell'amministrazione a modernizzarsi e a riformarsi»“ . Molto poco del resto è stato fatto per risolvere quello che di gran lunga costituisce il maggiore problema del paese, la spaventosa crescita demografica con il sovraffollamento delle campagne e del Cairo, che con i suoi oltre 13 milioni di abitanti rappresenta una delle città più invivibili del mondo.
Nel 1977 con un gesto spettacolare il Rais accettò di recarsi a Gerusalemme per una missione di pace che ebbe notevole successo. Alla Knesset, il parlamento dello stato ebraico, Sadat tenne uno storico discorso con il quale sostenne che in “Un mondo sconvolto da cruenti conflitti, traboccante di acute contraddizioni, minacciato periodicamente dalle guerre devastatrici che l'uomo intraprende per distruggere i propri simili. Al termine di queste lotte, in mezzo alle rovine di ciò che era stato costruito e tra i resti delle vittime umane, non ci può essere né vincitore né vinto. L'eterno sconfitto è l'uomo, la suprema creatura di Dio - l'essere umano creato da Dio, come ha detto Gandhi, l'apostolo della pace, «per camminare sulle proprie gambe, costruirsi la vita ed adorare Dio». Oggi sono venuto da voi ben saldo sulle mie gambe, affinché noi possiamo stabilire la pace per noi tutti su questa terra, la terra di Dio - noi tutti, mussulmani, cristiani ed ebrei allo stesso modo - e affinché noi possiamo adorare Dio, un dio i cui insegnamenti e comandamenti sono l'amore, la rettitudine, la purezza e la pace”, nel suo intervento il leader egiziano ricordò quindi che: “Se voi avete trovato la giustificazione legale e morale per lo stabilirsi di una patria nazionale su un territorio che non era il vostro, allora tanto più dovete comprendere la determinazione del popolo palestinese a costruire il proprio Stato una volta di più, nella sua patria” .
Con la mediazione americana nel marzo del '79 vennero firmati gli Accordi di Camp David, che prevedevano la restituzione del Sinai all'Egitto e l'autogoverno dei palestinesi, anche se non espressamente la piena sovranità del popolo arabo palestinese. I documenti sottoscritti vennero approvati successivamente in un referendum popolare ma suscitarono anche malcontento, e i paesi arabi riuniti alla conferenza di Bagdad decisero di condannare la pace separata dell'Egitto. Il governo del Cairo venne isolato dagli altri paesi arabi per aver abbandonato la causa del popolo palestinese, tuttavia i paesi del fronte della fermezza, Siria e Libia in particolare, adoperarono la questione dei territori occupati da Israele per i loro interessi e mostrarono di fatto ostilità nei confronti delle organizzazioni palestinesi ufficiali.
Nell'ottobre del 1981 il presidente egiziano venne ucciso da killer dei Fratelli Musulmani, gruppo al quale per ironia della sorte Sadat aveva aderito in età giovanile; tuttavia il nuovo governo guidato da Hosni Mubarak continuò quella politica di pace e di moderazione iniziata dal leader assassinato, riottenendo negli anni successivi il reintegro dell'Egitto nella Lega Araba e ponendo un freno all'azione dei governi arabi estremisti.
RADICALISMO E MODERAZIONE
NELLA REGIONE DEL MAGHREB
L'intera regione del Maghreb è stata soggetta al dominio francese, amministrazione che nel passato ha dato luogo a contrasti con le popolazioni locali superiori a quelli avvenuti nei territori amministrati dai britannici. La Gran Bretagna già negli anni antecedenti all'ultimo conflitto mondiale aveva introdotto nel suo impero delle riforme che avevano concesso un'ampia autonomia ai popoli sottomessi. Mentre la politica britannica tendeva al rispetto e all'autonomia delle popolazioni afroasiatiche, quella francese tendeva all'assimilazione, attraverso la concessione della cittadinanza francese agli indigeni più evoluti, cercando di fare di quelle nazioni dei territori francesi d'oltremare. La politica francese non ebbe successo e mentre il processo di decolonizzazione nelle colonie britanniche assumeva le caratteristiche di una “separazione consensuale”, in Vietnam, Siria, Marocco, Tunisia, Algeria e Madagascar si avevano tumulti e disordini sfociati in alcuni casi in autentiche guerre. La politica scarsamente realistica dei governi francesi (di destra e di sinistra) non trovò solidarietà a livello internazionale e lo stesso segretario di stato americano Dean Acheson nel 1949 affermò che il governo francese (e quello olandese) stavano seguendo una politica non accorta e che occorreva “sostituire l'insostenibile politica di oppressione coloniale con l'incoraggiamento e la cooperazione con i regimi coloniali indigeni” .
L'opposizione al dominio francese in Tunisia si manifestò in maniera precoce con la nascita del movimento dei Giovani Tunisini nel 1907 e del Destur (= costituzione) nel 1920, tuttavia il cammino verso l'indipendenza si presentò non facile. Alle richieste di maggiori libertà il governo francese oppose un deciso rifiuto decidendo lo scioglimento del Destur e del Neo-Destur, l'organizzazione fondata da Bourghiba, decisamente più laicista e modernista della precedente. Negli anni successivi in seguito anche alle massicce agitazioni del sindacato, che a differenza della maggior parte degli altri paesi afroasiatici si presentava attivo e diffuso nel paese, il governo di Mendes France accettò nel 1955 di aprire negoziati con l'opposizione, politica che provocò tuttavia la rottura fra Bourghiba e Ben Yussuf favorevole a sistemi di lotta illegali e all'alleanza con l'Egitto di Nasser.
Ottenuta l'indipendenza nel marzo del 1956, il bey di Tunisi venne destituito, e per un certo periodo di tempo la controversia con la Francia rimase aperta. Il governo di Bourghiba decise la nazionalizzazione delle terre appartenenti ai francesi e la revoca della concessione della base navale di Biserta, ma negli anni successivi procedette con maggiore moderazione ed evitò rotture con i paesi occidentali. Nel paese vennero introdotte riforme riguardo le condizioni della donna (divieto della poligamia e diritto di voto) e nel campo del diritto civile che consentirono una più ampia partecipazione popolare alla vita politica del paese. Anche se il paese non si è avviato verso una democrazia, e il partito socialista desturiano ha retto il paese in maniera ininterrotta fino a oggi, il governo ha quasi sempre dimostrato moderazione e un rispetto per i diritti umani superiore a quello dei paesi vicini. Anche Bourghiba come molti altri capi di stato del terzo Mondo tendeva a identificare sé stesso con lo stato, e non sfuggì al culto della personalità. Nei suoi lunghi anni di permanenza al potere, nelle piazze e sulla stampa il leader tunisino fu oggetto di grande esaltazione; secondo un giornale tunisino di quegli anni il personaggio era dotato di eccezionali qualità umane e politiche, “autoritario ma non dittatore perché soffrirebbe troppo di non essere amato” .
Nel lungo periodo di permanenza al potere di Bourghiba la Tunisia non conobbe opposizione, tuttavia secondo lo studioso francese Lacouture: “Un buon numero di intellettuali rimproverano al regime di proclamarsi «socialista» senza esserlo, deplorano la mancanza di qualsiasi serio dibattito, denunciano i «nuovi privilegiati» e criticano l'opportunismo degli «incondizionati»“ . Nel '64 venne tentato di dar vita ad una agricoltura collettivizzata attraverso la istituzioni di cooperative e la nazionalizzazione delle imprese, ma l'esperimento definito da alcuni come “'iniziativa settaria”, venne realizzato con eccessiva impazienza e brutalità provocando numerose proteste; il progetto venne criticato dallo stesso Bourghiba e nel '69 è stato definiti-vamente abbandonato.
All'interno del mondo arabo la Tunisia con decisione ha respinto le posizioni estremistiche, e il governo si è esplicitamente dichiarato per una sistemazione della annosa contesa arabo israeliana, arrivando a rompere nel '68 le relazioni diplomatiche con la Siria a causa della divergenza sulla questione. Alcuni anni più tardi il paese fu oggetto di interesse del potente vicino libico che organizzò un attentato alla vita del presidente. Dopo alcuni mesi di gravi tensioni la Tunisia con il sostegno delle altre nazioni arabe riuscì a prevalere sulle ambizioni del dittatore libico, che fu costretto a desistere dai suoi progetti di destabilizzazione.
Gli anni successivi furono caratterizzati da una relativa stabilità, nonostante alcune ondate di scioperi (per richieste più economiche che politiche) che non ebbero comunque eccessivo seguito. Nel 1987 il vecchio leader Bourghiba venne allontanato dal potere “per ragioni psicofisiche”, ma il nuovo governo diretto da Ben Alì continuò sostanzialmente la politica di moderazione del predecessore. La stabilità politica del paese ha favorito un relativo sviluppo economico e sebbene il paese sia molto meno ricco di risorse naturali dei paesi vicini gode di un livello di benessere certamente non inferiore .
Il nazionalismo marocchino ricevette notevole impulso dall'occupazione angloamericana nel 1942 e dalla promessa da parte del presidente americano Roosevelt di garantire l'indipendenza del paese, tuttavia gli sviluppi successivi conobbero un andamento molto più difficile. I francesi contrastarono l'Istqlal, il movimento indipendentista marocchino, e cercarono di sostituire il sultano Mohammed V con il più docile Mohammed Ben Arafa, ma i disordini seguiti a tale atto impedirono la riuscita del progetto, e nel marzo del '56 dovettero accordare la piena indipendenza al paese.
Nel 1958 il sultano accettò la delega di una parte dei suoi poteri al governo e la formazione di un'assemblea legislativa, ma le riforme risultarono limitate, e negli anni successivi non mancarono contrasti nel paese. Nel 1965 si ebbe la proclamazione dello stato d'emergenza a seguito di grandi scioperi e proteste studentesche che vennero represse con energia, e lo stesso De Gaulle intervenne duramente per criticare il comportamento del governo monarchico implicato nell'assassinio del principale esponente dell'opposizione Ben Barka. Negli anni successivi si ebbero diversi tentativi di colpi di stato e di attentati alla vita del monarca, finché nel '72 il sovrano non decise di allentare il suo autoritarismo e di concedere una nuova costituzione (la terza), che prevedeva più ampi poteri del Parlamento.
Negli anni Settanta si presentò la questione dell'annessione della ex colonia spagnola del Sahara occidentale, iniziativa che servì anche da collante interno del paese. Il governo marocchino e quello mauritano si accordarono per la spartizione del territorio (desertico, ma ricco di risorse minerarie), piano che incontrò la opposizione di un gruppo guerrigliero, il Polisario, sostenuto da Algeria e Libia. La questione su cui intervenne l'ONU e l'Organizzazione per l'Unità Africana, è risultata di difficile soluzione in quanto il territorio non è abitato da popolazioni stabili ma è sede di popolazioni nomadi di difficile identificazione, e nonostante i tentativi di mediazione la questione risulta tuttora aperta.
L'economia del paese ha risentito delle eccessive spese militari e dello sfavorevole andamento del mercato dei fosfati, principale fonte di reddito del paese. La parziale riforma agraria e la pianificazione economica non hanno avuto successo, e nel 1981 e nel 1984 si ebbero nuovamente proteste popolari, che vennero represse duramente dal governo con alcune decine di morti; la situazione solo difficilmente è ritornata alla normalità.
Come in altre colonie francesi in Algeria i diritti delle popolazioni locali vennero sacrificati agli interessi della numerosa comunità francese presente, (circa un decimo della popolazione totale), e negli anni Trenta iniziarono a manifestarsi le prime forme di opposizione al dominio degli europei. La concessione della cittadinanza francese ad alcune decine di migliaia di mussulmani risultò del tutto insufficiente, e nel '45 si ebbero numerose manifestazioni contro il governo di Parigi. Successivamente venne concessa dalle autorità francesi la costituzione di una assemblea legislativa algerina, ma l'iniziativa venne respinta dalla popolazione in quanto la presenza araba all'interno di essa risultava notevolmente sottostimata.
I moti per l'indipendenza in Algeria hanno provocato numerose vittime e hanno avuto notevoli riflessi in Francia. L'Unione Democratica per il Manifesto Algerino (UDMA) e successivamente il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) diedero vita ad una intensa attività politica, militare e terroristica che provocò la reazione dei coloni e delle truppe francesi. Nel 1958 le due componenti costituirono un comitato di salute pubblica in contrasto con il governo di Parigi, e favorevole alla formazione di un governo di unità nazionale presieduto da De Gaulle. Il conflitto fra ribelli algerini e i francesi (sul quale il governo americano espresse numerose riserve) diede luogo a gravissime violenze di cui fecero in molti casi le spese i gruppi moderati europei e arabi favorevoli ad una soluzione negoziata. Nonostante nuove manifestazioni e nuovi pronunciamenti militari il governo francese dovette alla fine riconoscere nel '62 con gli Accordi di Evians l'indipendenza della colonia.
La nascita dello stato algerino fu contrassegnata da un periodo estremamente turbolento della vita del paese, che sembrò sfociare in una guerra civile fra le numerose formazioni politiche che avevano preso parte alla rivoluzione. Lo stesso Ben Bella ricorda in una sua autobiografia che l'FLN non aveva “né un programma né una dottrina. La Rivoluzione algerina era stata una rivoluzione senza ideologia. Lacuna che in tempo di guerra aveva permesso una larga convergenza di forze contro la dominazione coloniale, ma che ora tornata la pace, si dimostrava pericolosa” . Mentre 800.000 francesi furono costretti in condizioni tragiche ad abbandonare il paese, e molti algerini furono passati alle armi perché sospetti di collaborazionismo, si aprivano gli scontri fra il governo rivoluzionario di Ben Khedda e l'esercito di Boumedienne che negli anni passati non aveva preso parte al sommo-vimento insurrezionale. La fazione che faceva capo a Ben Bella, strettamente alleata a Boumedienne, rimproverava all'FLN la sua indigenza ideologica che “insieme alla sua mentalità feudale e allo spirito piccolo borghese che ne sono una conseguenza indiretta, rischia di far cadere il futuro stato algerino nelle mani di una burocrazia mediocre ed antipopolare nei fatti, se non nei principi” ma secondo esponenti sindacali gli stessi errori erano da attribuire anche al raggruppamento avversario. Lo scontro si risolse a favore di Ben Bella grazie all'intervento dell'esercito e in breve tempo tutti i principali capi rivoluzionari furono costretti a ritirarsi dal governo.
Il governo Ben Bella diede una svolta dittatoriale allo stato, e promosse alcune importanti riforme nel campo economico. La riforma agraria impostata dal governo nel 1963 aveva come obbiettivo “l'autogestione” delle terre da parte dei contadini riuniti in cooperativa, ma prevedeva in realtà a fianco dell'assemblea dei lavoratori un direttore di nomina statale con ampi poteri. Secondo lo studioso italiano Calchi Novati: “Le ingerenze burocratiche, l'impreparazione tecnica e culturale dei lavoratori e soprattutto la scarsa volontà politica dei pubblici poteri - restii ad affidare ad un'iniziativa sicuramente «popolare» la funzione traente di tutto il sistema - provocarono da una parte un rallentamento produttivo e dall'altra l'involuzione del settore verso una compiaciuta autodifesa degli interessi dei propri membri, anche nei confronti del resto del movimento contadino... le forze portate più verso il capitalismo di Stato che verso il socialismo diretto intervennero subito per chiudere l'esperimento dell'autogestione in un ambito ben delineato” . Nel campo industriale si procedette a numerose nazionalizzazioni realizzate con scarsa congruità. Nelle sue memorie Ben Bella mette in luce che le confische di beni, gli interventi sul mercato, vennero attuati colpendo piccole proprietà e attività che per loro natura (negozi, caffè, ristoranti) non si prestavano alla “socializzazione”.
L'estremismo di Ben Bella impedì l'afflusso di tecnici e capitali stranieri provocando un grave regresso economico del paese. Le esportazioni agricole nella prima metà degli anni Sessanta calarono del 30-40%, la produzione di fosfati, che costituivano la principale risorsa del paese, si ridusse di un terzo, mentre i pochi impianti industriali esistenti cessarono buona parte delle loro attività a causa delle difficoltà di approvvigionamento.
A differenza della vicina Tunisia le associazioni sindacali ebbero un ruolo molto limitato e subordinato alle direttive provenienti dall'alto. In base alla Carta di Algeri approvata dal partito unico nell'aprile del '64: “In regime capitalista, il sindacalismo è prevalentemente rivendicativo. Esso attraverso la rivendicazione economica, persegue una prospettiva politica. In un regime nel quale il potere appartiene agli operai e ai contadini, la prospettiva non può essere la stessa, e la contesa può assumere un pericoloso significato controrivoluzionario” .
La Carta di Algeri prevedeva una serie di importanti innovazioni in alcuni importanti settori della vita del paese. Per quanto riguarda la struttura politica dello stato si stabiliva che: “Il sistema pluripartitico non è un criterio della democrazia né della libertà. Esso corrisponde ad una determinata tappa dello sviluppo della società divisa in classi opposte”; il documento prevedeva inoltre che: “La giustizia deve essere nel suo funzionamento uno strumento di difesa degli interessi della rivoluzione e non uno strumento al servizio di privilegiati, deve essere un mezzo di educazione delle masse e non di coercizione” . In maniera abbastanza singolare era previsto un particolare status dell'esercito, al quale era demandata non solo la difesa del paese, ma anche il suo intervento nelle decisioni politiche ed economiche; in base a tali asserzioni alle forze armate venne affidata la gestione di una parte rilevante delle terre coltivabili, provvedimento che ebbe risultati deludenti, e impedì la partecipazione delle popolazioni locali alla gestione delle risorse.
Nel campo della politica estera il governo Ben Bella inaugurò una politica di amicizia con l'Unione Sovietica e la Cina che ebbe come maggiore risultato il finanziamento di un grande centro siderurgico per 128 milioni di dollari. Il leader algerino si fece interprete delle istanze più estremistiche nel mondo politico africano e nel 1963 prese contatti con Cuba per la costituzione di un grande movimento antioccidentale. Il suo notevole attivismo politico non gli impedì comunque di essere rovesciato da un colpo di stato militare diretto dal suo ex alleato Boumedienne che nel 1965 lo privò di ogni potere.
Il nuovo governo inaugurò una gestione meno personalistica e più collegiale del potere, con un minore ricorso alla mobilitazione popolare, ma continuò sostanzialmente l'opera di Ben Bella. Nel campo economico vennero nazionalizzati quei settori sfuggiti alla statalizzazione disordinata del periodo precedente, e venne tentato attraverso un aumento del prelievo fiscale di promuovere un programma di industrializzazione. Tale politica non fu comunque in grado di risolvere l'annoso problema della disoccupazione, che ha trovato una parziale soluzione solo con una massiccia emigrazione verso l'antica potenza colonizzatrice, con la quale il governo algerino ha cercato di ristabilire buoni rapporti.
Anche Boumedienne fu un sostenitore del panarabismo, ma in polemica con Nasser riteneva che tale progetto non si dovesse realizzare attraverso accordi formali a livello di governo; nella Carta Nazionale del 1976 si legge infatti che “L'unità è un urgente imperativo per il popolo arabo... Perché essa sia duratura non deve essere né il risultato di semplici accordi tra governi né tanto meno, il prodotto di situazioni congiunturali... Sono le trasformazioni economiche e sociali, come le scelte politiche che esse implicano a livello di massa, a costituire il fattore determinante per l'attuazione di questa impresa storica” .
Con il suo radicalismo antiisraeliano, le sue prese di posizione estremistiche sulla questione petrolifera, e i suoi legami con l'URSS, l'Algeria cercò di candidarsi alla guida del mondo arabo ma con scarso successo, e negli anni successivi si ebbero nuovamente periodi di forte tensione con il vicino Marocco. Boumedienne cercò di dare vita nel 1974 con Cuba e il Vietnam del nord ad una nuova formazione politica mondiale che unisse i paesi poveri del mondo nella lotta ai paesi ricchi, ma non ebbe molto successo; i paesi poveri del Terzo Mondo ritenevano che i paesi arabi fossero più intenti a sostenere per i loro fini il prezzo del petrolio che portare avanti la causa dei popoli diseredati.
Una maggiore moderazione politica e nel campo economico una liberalizzazione delle attività produttive, grazie anche al miglioramento dei rapporti con i paesi europei, si è avuto negli anni successivi con il governo Chadli.
Nel 1969 un colpo di stato militare rovesciò il re Idris, capo della confraternita dei Senussi che negli anni passati aveva combattuto il dominio italiano, e instaurò la repubblica. La rivolta guidata dal colonnello Gheddafi seguiva un periodo di malcontento popolare a causa della corruzione e della politica filooccidentale della monarchia. L'azione condotta dagli Ufficiali Unionisti Liberi venne sostenuta dal governo egiziano di Nasser e destò preoccupazione in Occidente, tuttavia il governo francese di Ponpidou sembrò salutare con piacere la caduta di uno degli ultimi paesi filobritannici, e nel gennaio dell'anno successivo venne sottoscritto un accordo fra i due paesi per la vendita di armi.
Il primo comunicato del Consiglio del Comando della Rivoluzione all'indomani dell'insurrezione conteneva già molte indicazioni sulla futura politica di governo; in esso si esprimeva: “La propria incrollabile volontà di edificare una Libia rivoluzionaria, una Libia socialista scaturita dalle realtà che le sono proprie ed aliena da qualsiasi dottrina; una Libia che nutra fiducia nel processo di evoluzione storica destinato a trasformarla, da paese sottosviluppato e malgovernato, in un paese progressista, pronto a lottare contro il colonialismo e l'imperialismo e a soccorrere le nazioni ancora colonizzate. Il Consiglio della Rivoluzione dà grande importanza all'unione dei paesi del Terzo Mondo, nonché alla battaglia contro il sottosviluppo sociale ed economico. Crede profondamente nella libertà di culto e nei valori morali contenuti nel Corano, e si impegna ad agire per difenderli e salvaguardarli” . In un successivo discorso il colonnello Gheddafi chiarì alcuni principi ispiratrici della rivoluzione: “Per Libertà noi intendiamo una libertà ad un tempo individuale e nazionale, che elimini la povertà, la colonizzazione, la presenza sul nostro territorio di truppe straniere. Per Unità, intendiamo l'unità di tutti i popoli arabi, ch'essa si estrinsechi sotto forma di un unico grande governo arabo o sotto forma di una federazione di piccoli governi: ciò dipenderà dalle circostanze. Per Socialismo, infine, intendiamo anzitutto un socialismo islamico. Noi siamo una nazione mussulmana: rispetteremo perciò, come ingiunge il Corano, il principio della proprietà privata, anche quando si tratti di proprietà ereditaria. Ma il capitale nazionale godrà di privilegi, affinché possa contribuire allo sviluppo del paese” .
I primi provvedimenti emessi dal nuovo governo andavano verso una restrizione delle libertà ed una concentrazione dei poteri; venne disposta la nazionalizzazione delle banche e delle compagnie petrolifere, imposte restrizioni al commercio con l'estero, oltre ad una serie di provvedimenti economici (aumenti nominali dei salari e riduzione degli affitti) scarsamente efficaci, e il rialzo del prezzo del petrolio. Contemporaneamente si ebbero alcune decisioni di grande gravità come l'espulsione della comunità italiana dal paese, l'introduzione della pena di morte per chi contestava il governo, l'evacuazione delle basi angloamericane, e la proclamazione dell'Islam come religione di stato. Sotto certi punti di vista il paese conobbe in quegli anni una netta involuzione; vennero abolite le autonomie di cui godevano da sempre le popolazioni beduine, vennero chiusi i locali di divertimento, e proibito l'alcool anche ai non mussulmani. Secondo la testimonianza del giornalista di origine araba Benjamin Kyle “Ci furono moti di rabbia alla chiusura delle taverne e in seguito alla nuova legislazione che vietava i jeans e i capelli lunghi. Le donne vennero colpite dalle nuove leggi governative riguardanti la lunghezza delle gonne, leggi il cui rispetto gli uomini della polizia imponevano marchiando con inchiostro indelebile le gambe delle donne che avevano un orlo troppo alto”.
La vasta raccolta di testimonianze della studiosa italiana Mirella Bianco sul leader della rivoluzione libica mette in luce le numerose superficialità e contraddizioni della politica del governo di Tripoli. Gheddafi parlando della rivoluzione culturale cinese ne attribuì esplicitamente la paternità all'Islam, e sostenne che l'autorizzazione alla costituzione dei partiti rappresentava un pericolo per il paese costituendo un elemento di rottura della compagine sociale. Anche il mondo della cultura subì un drastico giro di vite con la messa al bando di opere di molti autori “depravati”, fra le quali quelle del filosofo francese Jean Paul Sartre. Nei Cinque Principi che sono alla base del nuovo stato il dittatore affermò la necessità della “Epurazione di tutti i «malati politici» del paese. La libertà dev'essere la libertà del popolo, non quella dei nemici del popolo. Dev'essere appannaggio di tutti, e non di uno su dieci, a detrimento degli altri nove... Chiunque parli di comunismo, di ateismo o di marxismo sarà messo da parte e imprigionato. Allo stesso modo, se dovessimo scoprire che un Fratello Mussulmano o un membro del Partito islamico di liberazione ha intrapreso un'attività segreta, considereremo questa iniziativa come sovversiva e controrivoluzionaria, e li metteremo in prigione”.
Il sistema politico inaugurato da Gheddafi si basava non su partiti e rappresentanti, ma su “comitati popolari” in grado di costituire una sorta di “democrazia diretta” (progetto che ricordava in qualche modo quello di Sukarno in Indonesia), sistema che costituiva in realtà una forma di controllo del vertice sulla base, e negli anni successivi molti oppositori del regime all'interno e all'esterno del paese vennero uccisi o imprigionati.
Il dittatore libico nel corso degli anni si è lanciato nel campo della teorizzazione politica, elaborando il cosiddetto “Terzo Sistema” dove sosteneva che “Il capitalismo dando briglia sciolta all'individuo senza alcuna restrizione, ha trasformato la società in una vera e propria baraonda, la pretesa del comunismo di trovare la soluzione dei problemi nella soppressione totale e definitiva della proprietà privata, ha finito, dal canto suo, col trasformare gli individui in un branco di pecore. In quest'ultimo caso è il partito comunista a detenere tutto il potere e tutta la ricchezza, proprio allo stesso modo in cui la classe capitalista li monopolizza, da parte sua, nella società capitalista” . Nel Libro Verde Gheddafi cercava di delineare una nuova concezione politica di interesse mondiale. Si denunciavano come false la democrazia occidentale, il sistema dei partiti e finanche lo strumento del referendum, si considerava come valido unicamente il sistema incentrato sulla democrazia diretta fondata su comitati popolari e associazioni sindacali, che secondo l'autore costituivano, l'unica reale forma di democrazia.
Nel campo della politica estera è da ricordare l'intransigenza del governo libico verso Israele, del quale si chiedeva espressamente la sua distruzione, ma anche i pessimi rapporti con le organizzazioni palestinesi ufficiali, la rottura dei rapporti diplomatici con diversi paesi fra cui la Giordania e Marocco, le interferenze nella vita politica di Tunisia ed Egitto, l'invasione del Ciad. In particolare il regime libico è ricordato per il suo ricorso alla minaccia e il suo sostegno a numerosi movimenti terroristici (anche non mediorientali) e fonti libiche ufficiali nel passato hanno definito “atti eroici” alcuni dei peggiori atti di efferatezza compiuti in questi anni.
Nonostante le enormi ricchezze accumulate dallo stato libico con il petrolio, la popolazione ha risentito scarsamente dei benefici di questo afflusso di capitali, e per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza sociale la situazione del paese non è sostanzialmente diversa da quella dei paesi più poveri della regione.
IL DRAMMA DELLA PALESTINA
E IL TERRORISMO INTERNAZIONALE
In seguito alla guerra del '48 il territorio palestinese era stato assorbito interamente da Israele e dai paesi arabi vicini, Giordania ed Egitto, e circa mezzo milione di arabi palestinesi avevano abbandonato le loro terre d'origine.
Con la successiva guerra del '67 si ebbe una nuova ondata di profughi verso i paesi arabi vicini; negli anni Settanta fra crescita demografica e nuovi arrivati si contavano oltre un milione e mezzo di rifugiati, un terzo dei quali ospitati nei miseri campi d'oltre confine assistiti unicamente dalle organizzazioni umanitarie dell'ONU. Secondo gli arabi le popolazioni palestinesi erano state scacciate con la forza dalle loro terre, mentre secondo il governo israeliano furono invece i capi politici dei paesi ospitanti a ordinare il trasferimento delle popolazioni palestinesi; le condizioni difficili di questi profughi che non riuscirono ad integrarsi nelle nazioni ospiti favorirono la nascita di numerosi movimenti estremistici. Quella dei palestinesi non fu comunque l'unica tragedia di quel periodo, negli stessi anni un numero quasi uguale di ebrei sefarditi venne allontanato dai paesi arabi nei quali risiedevano da molte generazioni, e costretti a riparare in Israele.
Il nuovo esodo rafforzò le nuove organizzazioni palestinesi e diede un notevole impulso ad una nuova strategia politica che divenne tristemente famosa negli anni successivi, il terrorismo, condotto a livello internazionale contro obbiettivi di natura diversa. Nel 1968 accanto all'organizzazione di Al Fatah (= la vittoria) presieduta da Arafat, all'interno della quale erano ospitati esponenti di tendenze politiche diverse e con diverse fonti di finanziamento (la principale comunque rimaneva l'Arabia Saudita), sorsero diverse altre organizzazioni, alcune delle quali in aperto contrasto con l'Organizzazione per Liberazione della Palestina, che costituiva la rappresentanza legittima dei palestinesi. Fra le numerose organizzazioni si distinguevano il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina (FPLP) di George Habbash di tendenze marxiste e contrario non solo a Israele ma anche a tutti i paesi conservatori dell'area mediorientale, il Fronte Democratico Popolare di liberazione della Palestina (FDPLP) derivazione del precedente e maggiormente legato all’Unione Sovietica, il gruppo di Abu Nidal responsabile delle più turpi azioni di violenza, dell'assassinio di uomini vicini ad Arafat, e legato al narcotraffico.
Mentre l'organizzazione di Arafat conduceva un tipo di azione essenzialmente militare contro le forze israeliane (Settembre Nero più estremista sfuggiva probabilmente al controllo del presidente dell'OLP), le altre organizzazioni si abbandonarono ad azioni di terrorismo nel corso delle quali non venne risparmiata la vita di innocenti e di cittadini di paesi estranei al conflitto la cui unica colpa era quella di trovarsi nel posto sbagliato. Alcune delle azioni dell'FPLP in particolare vennero duramente condannate dal Comando unificato palestinese.
I palestinesi si trovarono a combattere non solo contro gli israeliani. In Giordania e Libano tentarono di costituire un loro stato autonomo ostile alle nazioni ospitanti. Si ebbero pesanti scontri, e in diverse occasioni l’organizzazione militare palestinese fu sul punto di essere distrutta. Tali eventi spinsero la organizzazione presieduta da Yasser Arafat a perseguire alleanze diverse, aprendo ai governi arabi moderati, e ad iniziare un lento processo di pace con Israele.
Arafat, riconosciuto (anche internazionalmente) come l'uomo più rappresentativo del mondo palestinese, seppe dosare con abilità estremismo e moderazione. Nel '72 così sintetizzò il programma del suo movimento: “La fine di Israele è lo scopo della nostra lotta, ed essa non ammette né compromessi né mediazioni. I punti di questa lotta, che piacciano o non piacciano ai nostri amici, resteranno sempre fissati nei principi che enumerammo nel 1965 con la creazione di Al Fatah [abrogati invece nel 1989]. Primo: la violenza rivoluzionaria è il solo sistema per liberare la terra dei nostri padri; secondo: lo scopo di questa violenza è di liquidare il sionismo in tutte le sue forme politiche, economiche, militari e cacciarlo per sempre dalla Palestina; terzo: la nostra azione rivoluzionaria dev'essere sempre indipendente da qualsiasi controllo di partito o di Stato; quarto: questa azione sarà di lunga durata. Conosciamo le intenzioni di alcuni capi arabi: risolvere il conflitto con un accordo pacifico. Quando questo accadrà ci opporremo” . Tale programma non costituiva una novità, e la Carta Nazionale Palestinese del 1964 risultava ispirata agli stessi principi. Successivamente alla guerra dello Yom Kippur, tuttavia il leader palestinese rivide progressivamente le sue posizioni. Nel novembre del 1974 invitato a tenere una relazione all'Assemblea Generale delle NU Arafat affermò: “Colui che lotta per una causa giusta, colui che lotta per ottenere la liberazione del suo Paese, colui che lotta contro l'invasione e contro lo sfruttamento, come contro la colonizzazione, non può mai essere definito terrorista... Sono venuto qui tenendo in una mano il ramoscello d'ulivo e nell'altra il mio fucile di rivoluzionario. Non lasciate che il mio ramoscello d'ulivo cada dalla mia mano” .
Ai propositi più moderati Arafat fece seguire la rottura con il fronte arabo estremista formato da Siria, Libia e Irak, e la ripresa di rapporti con re Hussein. Molti paesi arabi avevano interesse che la “ferita” della Palestina non si richiudesse, e nel maggio del 1983 gruppi palestinesi filosiriani cercarono di rovesciare Arafat e di porre l'assedio ai campi profughi di Tripoli in Libano, ma il tentativo di creare un movimento palestinese allineato non ebbe successo. Coronamento della nuova politica palestinese fu nell'87 la proclamazione di una nuova forma di lotta non cruenta, l'intifadah, con la quale i giovani palestinesi hanno cercato di mettere in difficoltà l'esercito israeliano. La rivolta delle pietre, come è stata definita in Occidente, ha messo seriamente in crisi la credibilità del governo israeliano e ha contribuito a dare una nuova immagine al movimento palestinese di fronte all'opinione pubblica mondiale.
Per molti anni George Habbash, un palestinese di fede cristiana ortodossa, fu il principale avversario di Arafat e l'uomo che più di ogni altro legò la causa palestinese ad una soluzione rivoluzionaria; secondo il capo dell'FPLP “Israele è un fenomeno colonialista, il colonialismo è un fenomeno imperialista, l'imperialismo è un fenomeno capitalista: quindi i soli paesi che consideriamo amici, e ai quali non ci sogniamo di dirottare gli aerei, sono i paesi socialisti. Il paese più amico di tutti è la Cina” . Nel corso degli anni il movimento terroristico da lui diretto rivendicò numerose azioni fra le quali il triplice dirottamento aereo del settembre 1970 in Giordania e il massacro all'aeroporto israeliano di Lod alcuni anni dopo, condotte sempre con freddezza e notevole professionalità.
Nel '73 successivamente alla terza guerra arabo israeliana venne lanciata la maggiore sfida dei paesi produttori di materie prime ai paesi occidentali. Il rialzo del prezzo del petrolio deciso dai paesi dell'OPEC nell'ottobre di quell'anno colpì i paesi europei ritenuti ingiustamente filo israeliani, ma colpì in eguale misura anche quei paesi poveri come l'India che dipendevano dal petrolio come principale fonte di energia.
Di fronte all'iniziativa che vedeva su posizioni comuni monarchie conservatrici e paesi rivoluzionari (anche se nella fase successiva furono soprattutto quest'ultimi a sostenere una politica di scontro con i paesi occidentali) la risposta dell'Occidente fu debole; gli Stati Uniti cercarono di costituire un fronte unico dei paesi consumatori di petrolio ma incontrò l'opposizione della Francia e del Giappone più favorevoli al compromesso. Kissinger nelle sue memorie ricorda che il timore dei governi occidentali che una qualche iniziativa avesse potuto inasprire la politica dell'OPEC paralizzò il mondo occidentale, e che: “Ancor più grave della rivoluzione economica fu l'emergere del petrolio come arma di ricatto politico... Se mai è stato vero che gli aiuti economici erano necessari per impedire la divisione del nostro pianeta tra i pochi che possedevano la ricchezza e i tanti che vivevano nella miseria, e se il mantenimento della pace ci imponeva di chiudere il varco, allora l'aumento del prezzo del petrolio ha agito mirabilmente per impedire il raggiungimento di questi obbiettivi. Quasi tutti i paesi in via di sviluppo dipendono totalmente dalle importazioni di petrolio per la loro espansione industriale e agricola, e tutto dipende dal potenziamento del commercio mondiale e degli investimenti oltre che dagli aiuti ai paesi stessi. Le speranze di questi paesi nel progresso vennero infrante dall'esplosione dei prezzi del petrolio” .
Il brusco rialzo del prezzo del petrolio ebbe come conseguenza un aumento dell'inflazione, della disoccupazione e una recessione nel settore industriale, senza produrre apprezzabili benefici reali per i paesi produttori di materie prime: investimenti mal coordinati nell'acquisto di holding internazionali, e incremento delle spese militari non consentirono né il miglioramento delle condizioni di vita delle masse arabe né il decollo economico di quella parte del mondo.
Dalla fine degli anni Sessanta si ebbe un incredibile aumento dell'attività terroristica internazionale con dirottamenti aerei, sequestri di persona, attentati, alcuni dei quali condotti in collaborazione con gruppi terroristici tedeschi e di altre nazionalità, contro obbiettivi civili nei paesi europei. Il successo dell'ondata di terrore determinò una serie di azioni che non avevano più nulla in comune con la questione palestinese (in quegli anni vennero uccisi anche diversi collaboratori di Arafat), e che costituirono una sorta di terrorismo su commissione. Sebbene numerosi gruppi terroristici fossero formati da militanti palestinesi, e una parte degli attentati interessava la regione mediorientale, il nuovo terrorismo aveva finalità diverse e si presentava con le caratteristiche di una organizzazione professionale verticistica. La nuova ondata di terrore venne alimentata dai nuovi regimi creatisi nella regione: l'Iran di Khomeini, la Siria di Assad, la Libia di Gheddafi, e tendeva a neutralizzare l'azione dei paesi occidentali e a combattere i paesi arabi moderati. Nel 1973 si ebbe l'attacco ad un aereo della Pan Am all'aeroporto di Roma, condotto da gruppi ben addestrati, che si concluse con la morte di 32 persone del tutto estranee che si trovavano in quel luogo. Due anni dopo si ebbe ad opera del terrorista Carlos alias Ramirez Sanchez, il sequestro dei ministri del petrolio riuniti in una conferenza dell'OPEC; l'azione ispirata probabil-mente dalla Libia, si concluse con notevoli richieste di denaro e diede notevole impulso alla nuova strategia. Negli anni successivi molte operazioni commissionate dai governi libico, siriano ed iraniano diedero luogo a numerosi atti di efferatezza (talvolta compiuti dagli stessi diplomatici mediorientali accreditati nelle capitali europee) contro i quali i tradizionali sistemi di difesa passiva organizzati dai paesi occidentali risultavano inidonei.
Nel 1985 l'attività terroristica raggiunse il culmine con il duplice attentato all'aeroporto di Roma e Vienna nel corso del quale vennero uccise 15 persone definito da fonti ufficiali libiche come "atti di eroismo". Un salto nella strategia di repressione al terrorismo si ebbe con il presidente americano Ronald Reagan, il quale con alcune azioni aero-navali ben condotte riuscì a mettere fine al terrorismo libico e di riflesso a porre delle pesanti remore agli altri governi che adoperavano la medesima strategia. Con la rappresaglia americana del 1986 contro la Libia, nel corso della quale venne bombardata la stessa residenza di Gheddafi, il terrorismo ricevette un colpo dal quale non poté più riprendersi.
Trattando di Israele, dovremo innanzitutto stabilire se lo stato ebraico costituisca un paese del Terzo Mondo e se debba rientrare in questa dissertazione. Un problema ancora più complesso è stabilire la natura della nazione israeliana. Il giovane stato mediorientale è formato da genti che parlano lingue diverse che provengono in prevalenza dall'Europa centrorientale e dai paesi arabi; vi sono ebrei che certamente non appartengono alla stirpe originaria e che, come i falascia dell'Etiopia, sono razzialmente diversi, e vi sono infine cittadini israeliani che sono arabi che hanno preso la cittadinanza di Israele. L'unico legame di queste numerose comunità è sicuramente la religione, ma anche in questo campo ci sono le eccezioni e personaggi di primo piano della vita politica israeliana come la stessa Golda Meir, si professava apertamente non religiosa.
Nonostante la grande varietà etnica, Israele ha costituito e costituisce lo stato più saldo della regione avviato verso un regime democratico non diverso da quello dei paesi europei, anche se il timore dell'accerchiamento da parte dei paesi arabi ha condizionato notevolmente la sua politica interna ed estera e nel corso della sua breve storia non sono mancati episodi infelici di intolleranza.
La posizione di Ben Bella su Israele rispecchia una opinione per lungo tempo assai comune nel mondo arabo: “tra Israele e l'imperialismo occidentale c'è una sorta di intesa tacita: Israele dovrebbe sforzarsi di riprendere in Africa [e in Medio Oriente] le posizioni che gli occidentali sono stati costretti ad abbandonare: Così oggi il settantacinque per cento del commercio estero di Israele ha luogo con l'Africa del sud, cosa che dà da pensare se si tiene presente l'odiosa politica razzista di questo paese” . Secondo Arafat le cause del contrasto arabo-israeliano “non discendono da alcun conflitto religioso o nazionalistico. Non si tratta nemmeno di una disputa sui confini tra due stati vicini. Si tratta della causa di un popolo privato delle proprie terre natie, disperso e sradicato, che vive in gran parte in esilio e nei campi profughi” . Diverso è naturalmente il giudizio di molti uomini politici occidentali; secondo Kennedy gli americani dovevano sostenere Israele “di cui tutti gli amici della libertà debbono ammirare l'aderenza ai sistemi della democrazia. Ma facciamo anche in modo che sia chiaro a tutti i paesi del Medio Oriente, che noi vogliamo amici, non satelliti, e che a noi interessa la loro prosperità, quanto la nostra” .
Attraverso un grande impegno collettivo il paese fece enormi progressi, vennero notevolmente ampliate le superfici coltivabili strappate al deserto, e dato l'avvio all'industrializzazione. Oggi Israele è di gran lunga il paese più ricco della regione, e nonostante gli impegni militari che hanno gravato pesantemente sull'economia del paese, il tenore di vita non è molto diverso da quello dei paesi industrializzati dell'Occidente.
Alla prevalenza di governi di sinistra incentrati sul partito laburista, corrispose un orientamento socialista nel campo economico, di cui la gestione comunitaria delle terre costituiva l'aspetto più originale. Già prima del 1948 si organizzarono i moshav e i kibbutz. Nel primo la proprietà delle terre è individuale ma i capitali e gli strumenti sono di proprietà comune del villaggio, nel secondo l'aspetto collettivo è ancora più accentuato. Le terre coltivate sono di proprietà della comunità e i membri della stessa non percepiscono un reddito ma gli utili sono ripartiti equamente fra gli stessi. Non solo il lavoro, ma buona parte della vita, anche familiare, risulta comunitaria con mense e cura dei figli in comune. Secondo lo studioso André Chouraqui nel kibbutz “Il lavoro è offerto per amore del bene comune, e la comunità provvede, secondo le sue possibilità, ai bisogni di ciascuno. Una profonda sicurezza, fondata sulla fraterna solidarietà del gruppo dà a questi uomini senza denaro la ragionevole certezza d'essere i padroni del lavoro uscito dalle loro mani: uomini liberi” . Negli anni successivi, anche a seguito della grave inflazione abbattutasi nel paese, tale politica economica venne progressivamente abbandonata e sostituita con imprese che operavano sul mercato.
L'artefice dello stato ebraico e il protagonista di molte sue vicende fu un personaggio di notevole levatura morale, Ben Gurion, un uomo originale ed esuberante, di tendenze laiche di sinistra ma con una sua personale religiosità. Nella sua lunga carriera politica alternò all'attività di governo, impegni spirituali e l'interesse per l'agricoltura; venne criticato anche dal suo partito per il suo temperamento autoritario, ma lanciò anche diverse iniziative per la riconciliazione con l'Egitto. All'indomani della guerra del '67 affermò infatti che “Il vero successo per Israele non sta nel battere i suoi nemici esterni, ma nel vincere le sue battaglie con l'arida terra, nel far fiorire il deserto che costituisce il sessanta per cento del suo territorio” . Secondo quello che venne chiamato il padre della nuova patria israeliana, il rispetto della tradizione ebraica e la democrazia costituivano i cardini dello stato ebraico, e gli estremisti che volevano impossessarsi delle terre arabe rappresentavano una minaccia a questi principi, e un pericolo morale per la nazione.
LA PERIFERIA DEL MEDIO ORIENTE:
IRAN E TURCHIA
Iran e Turchia, sebbene appartenenti ad aree culturali profondamente diverse, la prima guarda più al mondo mussulmano e la seconda all'Europa, hanno conosciuto destini in parte simili con l'avvento negli anni fra le due guerre di guide politiche che hanno cercato di “svecchiare” il paese non senza il ricorso a metodi autoritari.
La Turchia fu il primo paese asiatico con la Cina di Chiang a compiere passi verso la modernizzazione e l'indipendenza del paese. La prima guerra mondiale portò al collasso l'impero ottomano e le grandi potenze europee approfittarono di tale situazione per stabilire una serie di trattati iniqui e lo smembramento della nazione turca. Il sultano accettò molte di queste condizioni in cambio della protezione occidentale, ma nel paese si creò un vasto movimento militare e popolare favorevole al rovesciamento della anacronistica monarchia che sotto la guida del generale Mustafà Kemal nel 1923 instaurò la repubblica. Dalla seconda metà degli anni Venti vennero introdotte numerose e significative riforme, l'emanazione di una legislazione di tipo occidentale, l'abolizione della poligamia, la laicizzazione dello stato, l'introduzione dell'alfabeto latino, e la creazione di un sistema scolastico di tipo moderno. Gli effetti furono notevoli anche sul piano economico con la realizzazione di numerose opere anche nel campo industriale, tuttavia sul piano politico si ebbero numerose persecuzioni contro l'opposizione politica e le minoranze etniche. Atatürk (= padre dei turchi) come venne chiamato Kemal, fece molto per impedire il collasso dello stato anatolico oggetto di interesse di numerose potenze e per la ricerca di un equilibrio internazionale a favore della Turchia; a tal fine per un certo periodo di tempo non disdegnò di stabilire buoni rapporti con l'Unione Sovietica in contrasto con le altre potenze europee.
Morto nel 1938 il padre della patria, successe al potere il suo braccio destro Inönü che per un certo periodo di tempo continuò la politica del predecessore, ma nel '46 acconsentì alla costituzione dei partiti e all'avvio della democrazia nel paese. Nei decenni seguenti la vita politica del paese fu contrassegnata dall'estendersi della corruzione, delle lotte personalistiche fra gruppi politici, e dall'intervento dei militari al potere che a più riprese diedero vita a dei governi d'emergenza.
Il paese ha conosciuto anche sul piano economico vicende alterne con periodi di grave inflazione e disoccupazione che hanno portato negli anni '78-'79 alle agitazioni di movimenti estremistici di destra e di sinistra. La situazione economica e politica del paese ha risentito notevolmente anche delle vicende di Cipro e della contesa con la Grecia, tuttavia il paese grazie agli aiuti della Comunità Europea e alla politica economica più liberale degli ultimi anni, ha conosciuto un discreto miglioramento e una situazione senz'altro migliore dei paesi vicini.
Analogamente alla Turchia gli appetiti delle grandi potenze sull'Iran e la debolezza della monarchia furono le cause di rivolgimenti in quel paese che consentirono al generale Reza Khan (successivamente Pahlavi), capo delle truppe speciali nel 1921 di marciare su Teheran, di deporre l'ultimo monarca della dinastia dei Cagiari, e di proclamarsi scià.
Negli anni successivi il nuovo monarca diede l'avvio a numerose riforme tese alla modernizzazione del paese, al potenziamento dello stato e alla limitazione dei privilegi del clero. Il programma di “europeizzazione” del paese fu più moderato di quello turco, comunque come Atatürk lo scià si batté con accanimento per affranca-re il paese dalle ingerenze straniere, e nel 1932 rinegoziò gli accordi per lo sfruttamento delle risorse petrolifere ottenendo una riduzione degli introiti a favore dei britannici.
Nel corso della seconda guerra mondiale russi e britannici d'accordo costrinsero lo scià, accusato di filogermanesimo, all'abdicazione e sul trono salì il figlio Mohammed Reza Pahlavi, personaggio per molti aspetti non meno energico del padre. Il suo regno venne scosso tuttavia dalla dura contrapposizione con il suo primo ministro Mossadeq. Il leader populista nel 1951 decise la nazionalizzazione dell'industria petrolifera suscitando il timore dei circoli di corte contrari ad uno stato di tensione eccessiva con la Gran Bretagna. Superato il contrasto con il sostegno dell'esercito, il re diede l'avvio ad un nuovo programma di riforme che prevedeva la distribuzione di terre dei latifondisti, il massiccio spostamento di una buona parte della popolazioni rurale nelle nuovi “unità agro-industriali”, e la soppressione di numerosi villaggi. Il progetto ebbe un limitato successo e non incontrò il sostegno delle popolazioni interessate, a causa della arbitrarietà di molti interventi. Lo scià mirava infatti a fare del paese una grande potenza mondiale ben oltre le possibilità reali della nazione, e a tal fine venne decisa la creazione di grandi complessi industriali gestiti dallo stato secondo principi vagamente socialisti che travolsero in breve tempo la fisionomia del paese, e provocarono notevoli trasformazioni nella vita delle zone rurali. L'esercito venne potenziato e l'Iran divenne nel giro di pochi anni la sesta potenza mondiale nel campo militare. Secondo il giornalista inglese Paul Johnson lo sviluppo economico previsto dalla rivoluzione bianca ricordava maggiormente la pianificazione economica dei paesi comunisti che il decollo economico dei paesi europei. L'azionariato operaio e le altre iniziative si rivelarono un insuccesso, aggravato dalle spese eccessive nel settore della difesa, e a metà degli anni Settanta si ebbe un significativo rallentamento della crescita economica. Esito più felice ebbe invece l'impegno nel campo dell'istruzione che migliorò la situazione di numerose regioni depresse.
La contraddizione fra miglioramento del livello culturale della nazione e mancanza di libertà non tardò a farsi sentire; i metodi autoritari, le manie di grandezza dello scià, il ricorso alla polizia segreta e la politica estera ritenuta eccessivamente filoamericana, suscitarono una vasta opposizione negli ambienti studenteschi e all'interno del clero sciita.
Le vicende iraniane hanno interessato notevolmente l'opinione pubblica internazionale. Secondo Indro Montanelli che aveva a lungo seguito lo sviluppo degli eventi, i movimenti contrari allo scià non avrebbero portato ad un miglioramento della situazione del paese, tuttavia era profondamente scettico sulla tenuta del regime monarchico; “Il regime dello Scià non è certo un modello di democrazia” scriveva nel settembre del '78 il nostro giornalista “Esso si regge più sulla repressione poliziesca che sul consenso del popolo. L'opposizione è imbavagliata. La ristretta casta che ha in monopolio il potere e gli stessi ambienti di Corte non sono modelli di rigoroso maneggio del denaro pubblico. E la corruzione non è nemmeno ripagata dall'efficienza, perché il progresso del Paese non è certo proporzionato agli enormi mezzi che gli assicura il petrolio: l'analfabetismo è ancora largamente diffuso, l'industrializzazione non decolla, l'amministrazione approssimativa e arbitraria. Insomma, nessuno dei secolari problemi che affliggono l'Iran e ne ritardano lo sviluppo è stato risolto” .
Nel '79 un lungo e sanguinoso braccio di ferro fra l'esercito fedele allo scià e l'opposizione si concluse con la cacciata dell'autocrate e l'instaurazione della repubblica islamica.