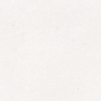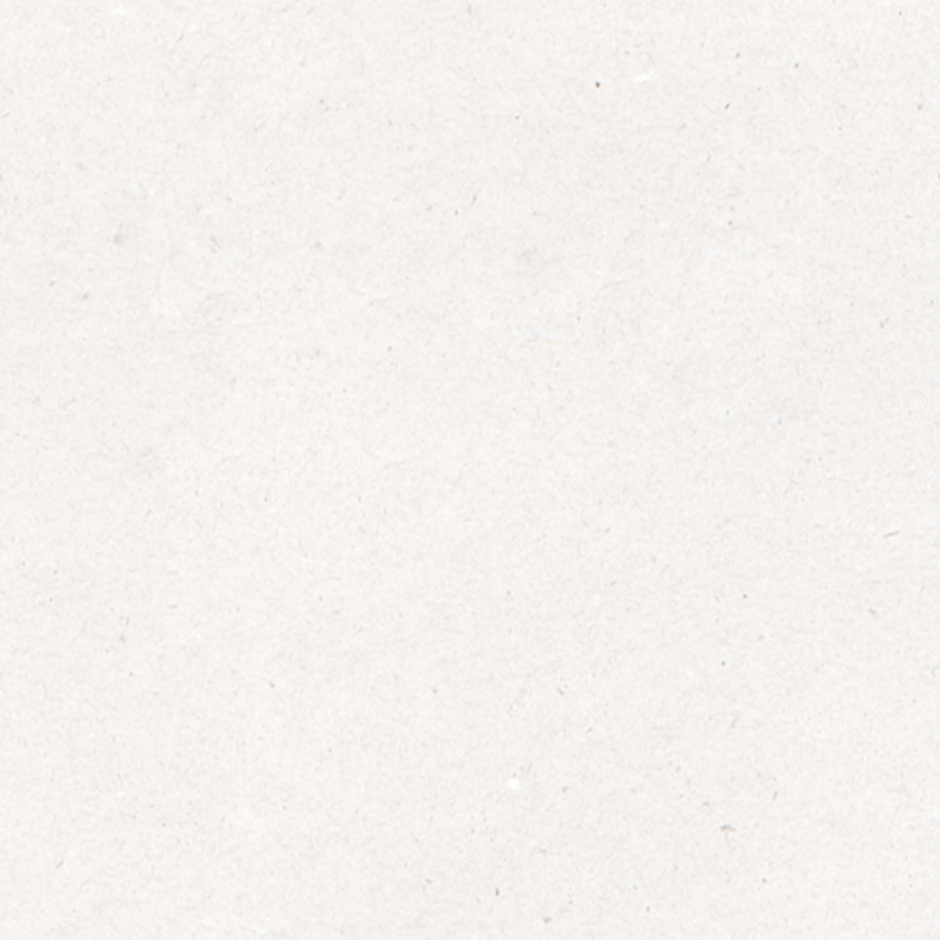parte 5°
i leader religiosi del mondo asiatico
LA RELIGIONE DELLA FRATELLANZA
DEL DALAI LAMA
Il Tibet è stato per lungo tempo uno dei paesi più singolari del continente asiatico, sorretto da una millenaria teocrazia, e con un sistema di governo interamente improntato sul buddismo mahayana. Per diverso tempo la regione è stata oggetto delle mire degli imperatori cinesi, ma al cadere della dinastia Manciù il regno divenne indipendente, legato da alcuni trattati all'India e alla Russia. Nel corso del nostro secolo il Tibet era vissuto in una sorta di isolamento culturale e materiale, privo di comunicazioni, con una economia molto arretrata come riconosciuto dallo stesso Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama.
Nel 1950 il Paese delle Nevi venne invaso dalle truppe cinesi che incontrarono una modesta resistenza a causa dell'arretratezza dell'esercito tibetano e del mancato sostegno di Gran Bretagna, Stati Uniti e dell'ONU in quel momento impegnati nella dura guerra di Corea. Per alcuni anni sembrò che i cinesi intendessero rispettare le autorità e le tradizioni locali, ma progressivamente la Repubblica Autonoma del Tibet venne ridotta ad una finzione e tutto il potere venne concentrato nelle mani del comandante dell'esercito d'occupazione. Il Dalai Lama mantenne un comportamento molto prudente e s'incontrò in più occasioni con Mao e Ciu En Lai per assicurare il suo impegno per contenere gli estremismi e favorire uno spirito di collaborazione con il governo di Pechino, ma senza risultato. Nel '59 la rivolta scoppiata nelle regioni orientali Tibet venne repressa con estrema durezza dalle autorità comuniste e una commissione internazionale dell'ONU inviata per studiare la situazione concluse che la politica cinese in Tibet aveva costituito una sorta di “genocidio culturale” di quel popolo. Molti monasteri vennero chiusi (e molti altri distrutti nel periodo della Rivoluzione Culturale), monaci e laici vennero inviati ai lavori forzati, e il paese integrato forzatamente nella repubblica popolare. Circa il 70% dei raccolti venne sottratto alle popolazioni locali con grave danno per il paese, e gli esponenti considerati non disposti a collaborare sottoposti al thamzing, una sorta di processi sommari davanti alle folle non diversi da quelli avvenuti negli anni precedenti nel resto della Cina. Secondo la testimonianza di Piero Verni nelle “sessioni di lotta” furono numerosi i casi di persone “obbligate ad accusare, ingiuriare, percuotere, lapidare degli innocenti, che non riuscirono a sopportare il peso di una tale umiliazione e preferirono suicidarsi” . il Dalai Lama e numerosi monaci, circa centomila, definiti “reazionari”, furono costretti a rifugiarsi in India mentre il giovanissimo e coraggioso Panchen lama per non essersi prestato alle accuse contro la propria gente venne inviato per quindici anni al campo di concentramento e successiva-mente morì in circostanze mai chiarite. Si ritiene che dal 1949 in seguito alle deportazioni e alle altre forme di maltrattamento, siano state circa un milione le vittime dell'occupazione cinese.
Il governo di Pechino nel corso degli anni ha cercato di porre fine alla resistenza tibetana attraverso un'opera di cinesizzazione forzata compiuta mediante la distruzione del patrimonio storico-artistico tibetano e il trasferimento di una numerosa colonia di cinesi Han in quelle terre. I cinesi hanno espresso critiche al sistema sociale feudale tibetano, ma la riforma agraria voluta dal governo comunista non ha fatto altro, secondo le parole del rappresentante indiano all'ONU, che “trasformare i piccoli proprietari in servi del regime”.
L'invasione del Tibet costituì certamente uno dei fatti più gravi avvenuti in Asia negli ultimi decenni ma anche uno dei meno dibattuti in sede politica, tale da suscitare scarso interesse presso l'ONU e le altre organizzazioni internazionali. La scelta del Dalai Lama e dei tibetani di ricorrere a manifestazioni di protesta pacifiche e di non ricorrere al terrorismo, come molti altri movimenti di liberazione, ha spinto molti a sottovalutare il problema di quel popolo.
In diverse occasioni il Dalai Lama ha manifestato l'opinione di non essere contrario a certi ideali socialisti né a cercare di migliorare i rapporti con i cinesi; in una recente intervista ha sostenuto che “Già in Tibet, particolarmente dopo il mio viaggio a Pechino, mi ero reso conto che nella nostra società c'erano diverse cose da riformare e cambiare... e se i cinesi me ne avessero lasciato al possibilità avrei dedicato tempo ed energie al graduale miglioramento della società tibetana. Ma vi erano dei cambiamenti da introdurre anche per quanto riguardava me stesso: il ruolo, la posizione, le funzioni del Dalai Lama. Fino ad allora c'erano stati troppi formalismi, troppe rigidità. Ora nelle difficili condizioni dell'esilio, le cose dovevano cambiare. Il Dalai Lama doveva essere più avvicinabile sia dalla sua gente sia dal mondo esterno” . Per i tibetani il Dalai Lama è Sua Santità, ovvero l'Oceano di Saggezza, secondo gli antichi titoli attribuiti alla sua persona, ma di sé stesso Tenzin Gyatso dice di essere un “monaco buddhista devoto ai principi di una religione basata sull'amore e sulla compassione” ed inoltre attribuisce grande importanza a tutti culti di cui ne è un profondo conoscitore. Nel suo discorso in occasione del ricevimento del Premio Nobel per la pace nel 1989 il Dalai Lama sostenne che: “Solo comprendendo che di fatto siamo tutti esseri umani ugualmente impegnati nel cercare la felicità e nell'evitare la sofferenza potremo sviluppare un sentimento di fratellanza universale e un profondo senso di amore e comprensione nei confronti degli altri... Il solo progresso materiale non è sufficiente per garantire la felicità degli esseri umani. Naturalmente questo tipo di progresso è importante. In Tibet abbiamo dato scarso rilievo allo sviluppo tecnologico ed economico e oggi ci rendiamo conto di aver sbagliato. Tuttavia il solo progresso materiale può causare seri problemi se non è accompagnato ad una crescita in campo spirituale. In alcuni paesi si attribuisce troppa importanza all'esteriorità e troppo poca alla ricerca interiore: credo che entrambe siano importanti e debbano essere coltivate insieme in modo equilibrato” .
Il Piano di Pace in cinque punti elaborato nel 1987 dal capo spirituale buddista rappresentava non solo uno strumento per la eliminazione delle tensioni in Tibet ma anche un importante documento politico per il mondo asiatico. Con esso il grande maestro proponeva che “Tutto il Tibet comprese le province orientali del Kham e Amdo, sia trasformato in una zona di «Ahimsa», termine hindi usato per significare uno stato di pace e di non-violenza. L'istituzione di una tale zona di pace sarebbe coerente con il ruolo storico del Tibet, di nazione buddhista neutrale e pacifica e stato-cuscinetto che separa le grandi potenze del continente”. Il documento denunciava inoltre che “Le violazioni dei diritti umani, sono in Tibet, fra le più serie del mondo. La discriminazione viene praticata come politica dell'«apartheid», che i cinesi chiamano «segregazione e assimilazione». Nel migliore dei casi i tibetani sono cittadini di seconda classe... sotto un'amministrazione coloniale” . Particolare importanza è attribuita alla questione ambientale; nel documento si sosteneva l'opportunità che i cinesi abbandonassero la politica di colonizzazione del paese, e l'uso di quel territorio come discarica di scorie radioattive, nonché la necessità di trasformare il grande altopiano himalayano in una grande riserva naturale, un luogo di studio e meditazione per tutte le popolazioni del mondo.
LA SOCIETÀ CHIUSA DI KHOMEINI
Nel mondo mussulmano la spinta propulsiva del socialismo laicista nasseriano si era fortemente affievolita, sia per gli insuccessi riportati nei vari conflitti di quell'epoca, sia per gli scarsi risultati nel campo economico e della politica interna. Una nuova forza politica si affacciava, l'integralismo religioso, con la sua carica emotiva e le sue scelte radicali, facendo la sua prima comparsa nell'Iran, un paese dove forti erano le tensioni politiche e sociali. La politica autoritaria dello scià aveva creato un duplice malcontento da parte dei gruppi studenteschi e da parte del clero sciita, che lamentavano non solo la mancanza di libertà ma anche l'eccessiva presenza americana nel paese. I fatti del 1979 e degli anni seguenti resero evidente che l'obbiettivo della rivoluzione non era solo la defenestrazione dell'odiato sovrano, ma anche la creazione di uno stato radicalmente diverso.
La repubblica islamica instaurata dopo la partenza dello scià presentava al suo interno una doppia struttura: da una parte il governo legale diretto da moderati e dall'altra i comitati islamici che agli ordini degli ayatollah prendevano provvedimenti contro chiunque fosse considerato un elemento sospetto, avesse commesso infrazioni alla legge islamica o avesse servito nelle precedenti istituzioni. Anche le leggi del paese presentavano una doppia procedura di approvazione, da parte del Parlamento e successivamente da parte del Consiglio islamico che sindacava sulla moralità delle norme. Ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione infatti: “La sovranità assoluta sul mondo e sull'uomo appartiene a Dio” , e pertanto tutta la legislazione doveva essere sottoposta al rigoroso controllo della gerarchia religiosa. Secondo la testimonianza del giornalista Amir Tahari “La rivoluzione mancando di qualsiasi programma di riforma socioeconomica, cercava di mantenere il suo slancio tramite esecuzioni, purghe, crescenti violenze contro le donne che non portavano il velo, pressioni per la totale messa al bando di musiche e balli, e continui attacchi allo scià e al suo defunto padre” . Nei primi due anni dalla proclamazione della repub-blica si ebbero 8.000 condanne a morte soprattutto contro militari, funzionari civili che avevano servito il precedente regime, membri di gruppi religiosi non ortodossi, curdi. Numerosi furono gli esiliati, e circa due milioni gli incarcerati. Nel 1989 quando morì l'ayatollah Khomeini, nel paese vi erano ancora 50.000 prigionieri politici e numerosissimi erano coloro che avevano subito torture.
Buona parte delle mode e dei beni di provenienza straniera vennero banditi dal paese, alle donne vennero imposte numerose limitazioni, fra le quali quello di coprirsi in pubblico. In un incontro con i direttori della radio nazionale l'imam Khomeini li esortò a combattere la mondanità e la musica “La musica corrompe le menti della nostra gioventù. Non c'è differenza fra la musica e l'oppio”. In un altro incontro a Qom l'ayatollah sostenne che: “Allah non creò l'uomo perché potesse divertirsi. Per l'umanità, lo scopo della creazione consiste nel mettersi alla prova tramite le privazioni e la preghiera. Un regime islamico deve essere serio in ogni campo. Non c'è umorismo nell'Islam. Non può esservi né allegria né gioia nelle cose serie. L'Islam non permette che ci si bagni nel mare ed è contrario ai serial radiotelevisivi” . Secondo lo studioso Seyyed Hossein Nasr “L'Islam essendo la religione dell'unità, non ha mai fatto distinzione, in nessun campo, fra ciò che è spirituale e ciò che è temporale, oppure fra religioso e profano. Il solo fatto che non vi sia neppure un adeguato vocabolo in arabo, persiano o altre lingue dell'Islam per esprimere il concetto di «temporale»,«secolare», è la prova migliore che l'astrazione corrispondente non esisteva nel pensiero islamico” . Sotto alcuni aspetti la rivoluzione islamica per il suo puritanesimo e per la sua idea di voler cambiare non solo le regole della società ma anche i singoli comportamenti umani, poteva ricordare la Rivoluzione Culturale realizzata alcuni anni prima in Cina, sebbene in un contesto ovviamente molto diverso.
Dopo la caduta della monarchia la Rivoluzione sembrava perdere la sua capacità di mobilitazione delle masse. Per galvanizzare nuovamente la popolazione venne deciso il sequestro del personale diplomatico statunitense, azione che provocò un'ulteriore radicalizzazione dello scontro politico, ma non molto tempo dopo la guerra con l'Irak costrinse gli estremisti a un temporaneo compromesso con l'esercito e quindi anche con la borghesia “laicista”. La terribile guerra costrinse a gravissimi sacrifici il paese che già attraversava un periodo economico difficile; per espresso ordine di Khomeini vennero inviati al fronte ragazzi di età di poco superiore ai dodici anni una parte dei quali impiegati in missioni suicide.
La politica e l'economia dell'Iran hanno subito notevoli vicissitudini nel periodo post-rivoluzionario; nel 1981 si ebbe una quasi guerra civile fra il i mujaiddhin e le guardie della rivoluzione, i pasdaran, sostenuti da Khomeini ma anche dal Tudeh, il partito comunista iraniano che per un certo periodo è stato l'alleato dei gruppi più radicali. L'economia del paese ha risentito notevolmente dell'isolamento a cui la nazione è stata sottoposta e della fuga di tecnici. Il fenomeno ebbe gravi conseguenze; come ricorda il Tahari negli anni Ottanta si ebbero più medici iraniani in Canada che nell'Iran. Secondo statistiche ufficiali il numero di persone “prive di casa o che vivevano in unità abitative insalubri” crebbe di circa cinque volte nello stesso periodo, e mentre in passato il paese era quasi autosufficiente in campo alimentare, nel 1989 era costretto a importare circa la metà del suo fabbisogno, mentre molte terre furono soggette a degrado ambientale a causa della politica dissennata condotta dal governo. Dal momento che i mullah non ritenevano la materia economica degna di interesse, né trovavano nel Corano precetti definiti da attuare, buona parte della precedente legislazione economica sopravvisse, tuttavia ciò non impedì il peggioramento della economia del paese.
La rivoluzione islamica non aveva come solo fine quello di imporre la shari'a nell'Iran, ma quello di sconvolgere l'intero mondo mussulmano e di creare una unica nazione rigorosamente sottoposta alla legge del Corano dal Marocco all'Indonesia. Tale opera tuttavia si è rivelata più difficile del previsto. Il fondamentalismo islamico con tutto il suo patrimonio di precetti e di limitazioni non ha conquistato le simpatie delle classi borghesi arabe, ma piuttosto di quelle masse diseredate che hanno poco da perdere dal rigorismo morale e che negli anni passati si erano sentite tradite dal socialismo laico terzomondista. Per questa ragione in molti paesi sebbene i fondamentalisti siano stati in grado di promuovere gigantesche manifestazioni, non hanno potuto mettere seriamente in crisi i governi locali, la cui struttura rimaneva saldamente nelle mani delle élite al potere.
Nel suo testamento politico l'imam indicava come obbiettivo per l'Iran di “Restare saldo e compatto sul sentiero tracciato da Dio senza confondersi né con l'Oriente ateo né con l'Occidente tirannico e blasfemo” , esortava i mussulmani di tutto il mondo a rovesciare i loro regimi e a unirsi nella Repubblica Islamica, e lanciava un durissimo appello contro la monarchia saudita alla quale andava sottratto il controllo dei luoghi santi. Dopo la morte di Khomeini comunque quasi silenziosamente una parte delle istituzioni islamiche più oppressive vennero rimosse, si riaffermò una certa tolleranza nei costumi, si mise fine alla politica aggressiva nei confronti di Arabia Saudita e Stati Uniti, e al sostegno al terrorismo internazionale.
In diversi paesi i fondamentalisti si sono dovuti appoggiare alle forze armate le quali hanno trovato nel rigorismo di facciata un valido strumento per imporre il loro arbitrio. Come altri movimenti privi di basi solide, il fondamentalismo in questi paesi era destinato a divenire un movimento di contestazione attraverso il quale veniva sfogata la rabbia delle popolazioni diseredate senza poter incidere sulle strutture di potere né consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, tuttavia in alcuni paesi, arabi e non, gli estremisti riportavano dei successi.
Nel Pakistan il governo islamico per un certo periodo assumeva delle posizioni antiamericane ma era costretto successivamente a recedere a seguito della disgregazione dello stato e della latente minaccia sovietica dal vicino Afghanistan. Analogamente nel Sudan un colpo di stato militare instaurava un regime fondamentalista. Il nuovo regime portava avanti una spietata guerra contro le popolazioni cristiane e animiste del sud, e in tutto il paese veniva imposta una rigida disciplina islamica, con il ricorso alla tortura, alle amputazioni e alle flagellazioni contro i presunti oppositori politici, ovvero per altri reati anche di scarsa gravità. Sebbene il governo di Khartoum non abbia assunto posizioni antioccidentali, per il suo orientamento contrario al rispetto dei diritti umani, si è progressivamente isolato dal resto della comunità internazionale.
In Algeria obbiettivo di primo piano degli integralisti algerini sono stati gli uomini di cultura, nel solo 1993 sono stati tredici gli intellettuali colpevoli solo di professare idee democratiche uccisi dagli estremisti. Nonostante la combattività del FIS, il partito islamico, le strutture dello stato apparivano solide e il governo militare sembrava reggere l'urto della mobilitazione di massa. Negli anni successivi lo scontro si è aggravato e di tale situazione ne ha fatto le spese la popolazione dei piccoli villaggi dell'interno; solo in anni recenti la situazione è migliorata.
Il fondamentalismo islamico ha anche fatto opera di proselitismo nelle repubbliche centro-asiatiche nate dalla disgregazione dell'Unione Sovietica. La costituzione di un partito islamico è stata la causa di una breve ma sanguinosa guerra civile nella piccola repubblica del Tagikistan, la cui vita politica ha risentito della sua posizione geografica in una zona calda del continente asiatico. Anche il vicino Afghanistan ha risentito dell'influsso islamico; dopo il ritiro dell'Armata Rossa, che negli anni passati aveva provocato un gran numero di vittime e di profughi, il paese - uno dei più poveri del mondo - è stato teatro di una guerra civile per motivi religiosi ed etnici. La successiva vittoria dei talebani, gli “studenti di teologia”, ha portato ad un regime oppressivo, che ha provocato un grave regresso economico.